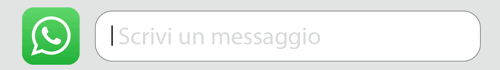Qual era il modello di business dell’Olivetti di Adriano, al di là dell’iniziativa elettronica (la realizzazione di uno dei primi grandi elaboratori elettronici del mondo, l’Elea 900), iniziativa senza dubbio importante, lungimirante, meravigliosa, ma soltanto parte della sua opera attraverso molti anni?
Si sono scritti volumi ma una quota abbondante dei racconti sull’intrapresa di Adriano era ed è, a mio giudizio, parto di sociologhi o politologhi che vi hanno visto, o infilato dentro, le loro mitologie, con scarse connessioni con la realtà fattuale. La vulgata è permeata di uno stereotipo che, rovesciando la verità e la logica, dà priorità a considerare gli aspetti sociali e politici, trascurando quelli di sostanza, cioè i fattori di economia industriale. È questa una stortura che, nata da opinionisti marxisti e cavalcata dai loro nipotini, ha condizionato molta pubblicistica italiana di ogni colore politico, oscurando la comprensione dei fenomeni reali.
Come guadagnare i soldi
L’Olivetti negli anni cinquanta non era – ante litteram – né “centro sociale” né espressione di “solidarietà”, ma una vera industria privata, e buona, una delle poche imprese in Italia di capitalismo moderno ed avanzato. E grazie alla coerente impostazione strutturale che aveva dato alla sua azienda Adriano possedeva una macchina per far soldi.
Prima ricetta: l’Olivetti privilegiava l’innovazione, la progettazione, il prodotto, e gestiva il processo tecnologico in modo integrato. I tecnici stavano al centro dell’attenzione della superiore direzione (ricordiamo che Adriano veniva di lì, e quello era rimasto il suo principale gusto) e godevano di grande fama, all’interno ed all’esterno del Gruppo, come il famoso Capellaro, che da operaio aveva percorso tutti i gradini fino a divenire capo della progettazione. E la stessa cosa valeva, per Mario Tchou, che Adriano aveva selezionato e fatto diventare direttore del Laboratorio di Ricerche Elettroniche. Per esperienza personale, essere un ingegnere dell’Olivetti voleva dire godere di un’etichetta di grande prestigio.
Ma ragioniamo con un caso effettivo. Prendiamo la Divisumma, per esempio, la calcolatrice da tavolo più popolare al mondo per almeno 10 anni, venduta in oltre un milione di esemplari (era la prima calcolatrice stampante in grado di eseguire le quattro operazioni e di dare risultati negativi): all’inizio degli anni 1960 veniva venduta per circa 110.000 lire. Produrla costava 15.000 lire (a livello di fabbrica, o – come noi dicevamo allora – a shop cost). Un margine immane, un mark-up tra i più elevati che io abbia mai attraverso gli anni riscontrato in un prodotto industriale complesso. Ad osservare la macchina nuda, senza la carrozzeria, mentre funzionava – supponiamo, a svolgere una lunga divisione – c’era da rimanere incantati: un gran numero di levette, intricatamente incrociate, si agitavano in maniera frenetica ed apparentemente disordinata, fino a quando, miracolosamente, compariva il risultato a stampa.
Eppure i pezzi che costituivano la Divisumma erano prodotti con pochi colpi di tranciatura fine su lamiera sottile o per sinterizzazione. Poi stuoli di operai li montavano insieme in pochi minuti.
Sì, proprio così, nelle fabbriche Olivetti si lavorava duro. In occasione del novantennio di Olivetti celebrato nel novembre 1998 a palazzo Colonna a Roma, un benevolente Bersani, allora ministro dell’industria, attribuì ad Adriano “il superamento del modello tayloristico” di produzione, ma il suo writer era in vena di leccate postume, o poco informato. Il lavoro operaio in Olivetti era a cottimo, come quello di ogni altra fabbrica di allora, né avrebbe potuto essere diversamente, anche se la parcellizzazione, e quindi la ripetitività del lavoro, non furono mai troppo spinte. Per esempio, nella seconda metà degli anni 1950 un operaio montava circa 15 macchine calcolatrici all’ora, 128 al giorno, un tempo-ciclo di 4 minuti. Il margine di Divisumma era da Guinness dei primati, ma molto alti erano i margini anche degli altri prodotti, dalle macchine per scrivere, soprattutto quelle alte di gamma come le elettriche, alle contabili per ufficio, le famose Audit, e alle telescriventi. La somma di questi profitti dava agli Olivetti, azienda e padroni, un reddito elevatissimo.
Seconda ricetta: Olivetti sapeva fare marketing e commercializzare. La rete di distribuzione era spendacciona, e mangiava una parte importante del margine lordo di fabbrica, ma si faceva perdonare perché era brava a vendere ed a promuovere la propria reputazione di modernità e di prestigio: il marchio Olivetti era famoso ovunque nel mondo. Il design delle macchine era strumentale a tale immagine ed i molti soldi spesi per architetti costosi e bizzarri ma geniali come Ettore Sottsass erano finalizzati a questo obiettivo. Lo stesso dicasi per i famosi negozi Olivetti.
La Divisumma 24, di cui ho parlato, oltre che una rivoluzione nel settore dei calcolatori automatici, è diventata anche un’icona del design industriale italiano, fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano, oltre ad essere conservata in molte esposizioni dedicate al design ed alla scienza e tecnica; e fa anche parte della collezione permanente del MoMA di New York.
C’è una somiglianza tra l’attuale successo di Apple e quello di Olivetti di oltre mezzo secolo fa, proprio per l’uso dei medesimi ingredienti: da un lato, innovazione esaltata da capacità produttiva di rapido intervento e di alta qualità, dall’altro lato, presenza di distribuzione internazionale supportata da immagine di leadership. Lo shop di Apple alla Central Station di New York è erede del negozio Olivetti nella Quinta Strada o in piazza San Marco di Venezia.
Se si considerano le iniziative di Adriano negli anni 1950 emerge con chiarezza la sua visione di grande strategia industriale: pilotare l’Olivetti verso lo sviluppo della moderna informatica e della internalizzazione. Basti pensare a:
- 1949: Olivetti Bull (centri meccanografici a schede, la prima informatizzazione dell’Italia);
- 1952: laboratorio elettronico di Canaan negli Stati Uniti e laboratorio elettronico di Pisa / Barbaricina (ove vennero progettati i grandi elaboratori elettronici Elea);
- 1955: fondazione della SGS (semiconduttori, l’attuale STMicroelectronic);
- 1958: controllo numerico delle macchine utensili.
L’acquisto di Underwood (1958), il più importante produttore di macchine da scrivere degli Stati Uniti, va visto in questa luce di grande respiro: svincolare l’Olivetti del futuro dal micro-contesto italiano, anche per allargare il mercato aziendale a favore della nascente elettronica. L’errore, che dopo la scomparsa di Adriano gravò sui conti ed i destini della Società, fu nel sotto-stimare l’arretratezza di Underwood e/o di sovra-stimare le capacità dell’Olivetti italiana di rimettere a posto la situazione. (Lo stesso errore fece la Fiat nel 1976 quando comprò la decotta Allis Chalmers per sviluppare il proprio settore di macchine movimento terra).
L’elettronica avvia l’uomo verso una nuova condizione di libertà e di conquiste
L’obiettivo di Adriano Olivetti era esplicitamente dichiarato già nel 1958:
“Nel campo dell’elettronica, ove soltanto le più grandi fabbriche americane hanno da anni la precedenza, lavoriamo metodicamente da quattro anni […]; noi non potremo essere assenti da questo settore per molti aspetti decisivo.”
L’8 novembre 1959, all’inaugurazione dell’Elea 1T nella sede milanese dell’Olivetti in via Clerici alla presenza del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Adriano Olivetti fece una dichiarazione che andrebbe insegnata e commentata nelle scuole:
“L’elettronica non solo ha reso possibile l’impiego dell’energia atomica e l’inizio dell’era spaziale, ma, attraverso la moltiplicazione di sempre più complessi ed esatti apparati di automazione, sta avviando l’uomo verso una nuova condizione di libertà e di conquiste. Sottratto alla più faticosa routine, dotato di strumenti di previsione, di elaborazione e di ordinamento, prima inimmaginabili, il responsabile di qualsiasi attività tecnica, produttiva, scientifica, può ora proporsi nuove, amplissime prospettive. La conoscenza sicura, istantanea e praticamente illimitata dei dati, l’immediata elaborazione degli stessi, la verifica delle più varie e complesse ipotesi, consentono oggi di raggiungere obbiettivi teorici e pratici che fino a ieri sarebbe stato assurdo proporsi, e di dirigere e reggere con visione netta e lontana le attività più diverse”.
Quale altro imprenditore o manager, e non soltanto in Italia, avrebbe avuto nel 1959 la straordinaria visione del futuro, e il coraggio, da saper e voler pronunciare tali parole profetiche? Ed ancora:
“Con la realizzazione dell’Elea, la nostra Società non estende semplicemente la sua tradizionale produzione ad un nuovo settore di vastissime possibilità, ma tocca una meta in cui direttamente s’invera quello che penso sia l’inalienabile, più alto fine che un’industria deve porsi di operare, cioè, non soltanto per l’affermazione del proprio nome e del proprio lavoro, ma per il progresso comune – economico, sociale, etico – della intera collettività”
Come spendere i soldi guadagnati
Dunque, in sintesi per l’Olivetti di allora: una grande capacità di specificare, progettare, produrre e vendere il prodotto, quindi una grande redditività del prodotto stesso, quindi un grande profitto per l’Azienda ed i suoi azionisti; i soldi venivano non da strategie cartacee o da ideologismi sociologici, né tantomeno dalla finanza o dai contributi e dalle concessioni di Stato, ma dal tecnigrafo, dalla linea di montaggio e dal negozio.
Adriano aveva contribuito, lui in prima persona, a mettere insieme tale patrimonio umano-industriale e aveva operato per creare un clima adatto alla sua espressione (nel 1962 io ero arrivato tardi in Azienda per vivere il momento della sua ideazione e del massimo fulgore della sua fioritura ma ancora in tempo per vederne i frutti). In quelle condizioni, Adriano poteva permettersi di spendere un sacco di soldi, e si diede a farlo in diversi rivoli con la stessa determinazione che aveva messo nell’Azienda per guadagnarli.
Per Olivetti, dunque, il driver non veniva dal versante del “sociale”, ma, al contrario, consentiva di sostenerlo. Perché, e qui sta la caratteristica più umana di Adriano, quello che lo differenzia da altri industriali di allora pur molto capaci: i profitti, che c’erano e venivano dall’industria, dovevano essere condivisi con la collettività, lui diceva comunità; andare per il benessere della gente, e non soltanto quello fisico ma anche, e soprattutto, quello psichico (la bellezza del luogo di lavoro, per esempio), e la collettività / comunità era per lui tutt’uno con il territorio.
Questa era la sostanza del messaggio di Adriano Olivetti, la diversità che lo rendeva così inviso alla maggioranza degli altri industriali incombenti, a cominciare da Valletta, e così osteggiato dai sindacati, dominati dall’ideologia e dall’obbedienza ai canoni marxisti, il cui obiettivo era esattamente l’opposto: dimostrare l’incompatibilità del sistema di produzione capitalistico con il benessere della popolazione per promuovere un sistema statalistico di controllo accentrato dell’economia e del modo di vivere della gente, sotto dittatura “del proletariato”.
La prima voce di spesa conduceva dunque al benessere dei dipendenti e del territorio, e questo impiego rafforzava l’immagine di Adriano benefattore che lo avrebbe giustamente per sempre contrassegnato. La lista degli interventi di welfare che l’Olivetti concedeva allora ai dipendenti è molto lunga, e la qualità di tali interventi era elevatissima. Cito alcune testimonianze di dipendenti di allora. Alle mense, soprattutto nell’immediato dopoguerra, “i dipendenti mangiavano meglio che a casa”. L’edilizia per i dipendenti corrispondeva “all’idea di mantenerli nei paesi in cui erano nati e in cui avevano un po’ di terra”. “Collegato a questo programma, c’era quello dei mezzi di trasporto, […] e anche gli studenti ed i famigliari dei dipendenti potevano salire sulle corriere aziendali”. “I nidi e le scuole materne avevano standard di un livello che io non ho più ritrovato da nessuna parte […] e l’attenzione, la cura erano molto intense e non si trattava di numeri piccoli: nei nidi c’erano 300 se non più bambini, mentre nelle scuole materne si è arrivati ad averne quasi 600”. Le lavoratrici stavano a casa, a stipendio pieno, tre mesi prima e sei mesi dopo il parto, più del doppio rispetto alle altre aziende. E poi, colonie estive ed invernali, formazione, assistenti sociali, centri di psicologia e psichiatria. Ed ancora, borse di studio, biblioteche a disposizione di tutti (90.000 volumi), cineclub, gruppo sportivo… Gli stessi interventi vennero immediatamente esportati allo stabilimento di Pozzuoli, inaugurato nel 1955, e persino si cercò di attuare qualcosa per la temporanea allocazione della fabbrica elettronica a Borgolombardo. Tutta questa attenzione non andava a genio ai vertici del sindacato, che si sentiva scavalcato nella ricerca del benessere operaio e tenuto lontano dalle stanze di controllo e condivisione delle erogazioni. L’usuale etichetta denigratoria era quella del “paternalismo”, ma la gente comune come me faticava a vedere cosa ci fosse di male nell’operato di un imprenditore “padre” e filantropo.

L’architettura industriale e l’accusa di “spreco”
Dato ad Adriano ciò che è di Adriano, va notato che anche altri imprenditori italiani degli anni 1950/60 attivarono pregevoli iniziative a scopi sociali. L’immagine del “padrone delle ferriere” non si addice a tutti. Per esempio, la “mutua Fiat” era eccellente anche per gli operai, e fu una grave colpa quella di aver livellato verso il basso l’assistenza sanitaria ai dipendenti, costringendo l’assistenza Fiat a confluire nell’Inam (fondato da Mussolini nel 1943 e confluito a sua volta nelle USL nel 1981), anziché il contrario, portare l’Inam alla qualità della mutua Fiat. Purtroppo, la spinta al livellamento verso il basso fu una colpa che difficilmente potrà essere perdonata ai partiti di allora anche in altri campi, per esempio in quello dell’istruzione, e le nefaste conseguenze dell’appiattimento salariale si fecero sentire sulle capacità progettuali di molte aziende, ad esempio di Fiat.
Un’altra strada, scarsamente percorsa da altri imprenditori e più tipica di Adriano, portava a iniziative culturali illuminate. Le più costose erano quelle dedicate all’ambiente di lavoro e quindi all’architettura industriale, come fu per il famoso stabilimento di Pozzuoli o, espressione sognata e mai realizzata, come sarebbe stato per l’edificio progettato da Le Corbusier destinato ad ospitare il comparto elettronico dell’Olivetti nell’informe pianura di Pregnana Milanese.
Proprio quest’ultima intenzione evidenzia un paradosso che aleggia attorno al mito di Adriano. Da un lato, l’Olivetti era finanziariamente instabile, soprattutto perché assente dalla grande finanza internazionale, tanto da essere costretta di lì a poco, al primo stormir di fronde (la crisi dei mercati nei primi anni 1960), a svendere il suo futuro, rappresentato dall’informatica elettronica. Da un altro lato, il grande architetto Le Corbusier, smisuratamente pagato, era chiamato ad ideare edifici che costituivano vero spreco di denaro se visti in un’ottica strettamente reddituale, critica frequente negli ambienti della finanza nazionale.
Il paradosso dell’approccio all’architettura industriale di Adriano Olivetti va confrontato con il fenomeno che si diffuse internazionalmente negli anni 2000 e 2010, e portò a costruire ovunque nel mondo edifici altissimi e bellissimi, la cui giustificazione economica è scarsa. Per esempio, il London Council negli anni 1990 decise che se si volevano autorizzazioni per costruire palazzi molto alti nella City i progetti dovevano avere pregi architettonici certificati da primari luminari, e nacquero così il “Gherkin” di Norman Foster (2001/2004) e lo “Shard” di Renzo Piano (2003/2013). Molti altri paesi si sono lanciati in opere altrettanto ardite ed emblematiche, quanto “inutilmente” costose. Un neo-olivettismo? Cosa avrebbero pensato i denigratori di allora dei grattacieli nati come smisurati funghi in Cina o in Malesia o nei paesi del Golfo?
Un altro capitolo di spesa consentiva ad Adriano Olivetti di mantenere una corte di intellettuali, o presunti tali, che contribuirono ad alimentare la sua immagine ma che sovente di loro mettevano soltanto parole, molte delle quali a vanvera. Nessuno amava dire che la fabbrica faceva i soldi e che loro li spendevano. Questi cantori giovarono alla sua fama, in allora e verso i posteri, ma furono dannosi per l’Azienda prima e per l’Augusto dopo la sua morte. Prima, perché fu anche a causa loro che l’Olivetti peccò di autocompiacimento, quella complacency che molti danni ha sempre fatto alle industrie di successo di tutto il mondo; dopo, facendo il gioco degli industriali culo-di-pietra alla Valletta, che sostenevano essere gli ideali di Adriano e della sua corte soltanto un insostenibile bluff. Ancor peggio: molti cortigiani sposarono poi la contrapposizione marxista tra lavoro e capitale, del tutto antitetica con il pensiero di Adriano, contribuendo a quel distacco, se non odio, che l’intellighenzia italiana dedicò ai valori dell’industria, stereotipo che fece dell’Italia un unicum al mondo, di un paese che di industria prosperava ma che sull’industria ci sputava sopra.
Adriano Olivetti: un giudizio con il senno di poi
Sessant’anni dopo la sua scomparsa, e con il senno di poi, è forse possibile tentare un giudizio equilibrato sull’operato politico di Adriano Olivetti, al di là del suo infelice tentativo di farsi eleggere al Parlamento. Inventare un nuovo partito (Comunità) e farsi votare senatore fu un errore tattico: l’azienda Olivetti, finché profittevole, era uno strumento ben più efficace di un seggio in assemblea, e non era il caso di porsi in concorrenza con i politici di professione (esattamente lo stesso errore, e con le stesse motivazioni altruistiche, fece Umberto Agnelli due decenni dopo.)
È però indubitabile che negli anni 1950 e 1960 (come nel caso di Agnelli negli anni 1970), in parallelo con l’industrializzazione del Paese e l’arricchimento che ne derivava per tutti, ricchi o poveri che fossero prima, erano attive rilevanti forze politiche tendenti a distruggere il modello capitalismo / libero mercato / democrazia parlamentare, per sostituirlo con il modello sovietico o con un inedito modello di democrazia statalista / oligarchica / parassitaria.
Gli industriali, in quanto soggetto politico di grande peso in un quadro più generale, avevano a disposizione diverse strade per contrare quelle deprecabili prospettive. La Fiat di Valletta negli anni 1950 e 1960, e con essa molti imprenditori del dopoguerra, avevano scelto la politica della contrapposizione a “muso duro” con i sindacati. Di qui derivavano gli atteggiamenti di rigore, o di vera e propria persecuzione, che erano attivati all’interno delle fabbriche nei confronti non soltanto dei sostenitori del cambio di regime ma anche dei moderati non allineati. A mio giudizio, e questa era la mia opinione già allora, tale scelta era controproducente. Serviva soltanto a rendere più conflittuali i rapporti di lavoro e ad accentuarne i toni. La controparte “rivoluzionaria” cavalcava agevolmente a proprio ulteriore vantaggio l’esasperazione indotta da tale condotta. Ancora adesso perdura lo stereotipo, vero soltanto in parte, della Fiat vallettiana come di un lager, e si ricorda l’epiteto di “la Feroce” con cui gli operai avevano battezzato la loro azienda: un’etichetta di stampo leninista non certo collaborativa… tanto più ingrata a fronte degli inusitati benefici ricevuti dagli immigrati dal Sud e dalle montagne del Nord grazie all’esistenza dell’Azienda medesima.
La Fiat di Gianni Agnelli cambiò registro a partire dagli anni 1970. “I governi di sinistra sono necessari per tenere tranquille le piazze, e quindi lasciarci fare i nostri affari”, fu, in soldoni, la filosofia di Gianni, che dichiarò esplicitamente ad un convegno a Cernobbio del 1996: “solo la sinistra può fare una politica di destra”. Questa strategia non venne gratis. Il prezzo da pagare fu quello di consentire alla controparte una martellante propaganda anti-capitalistica (sia pure sovente soltanto volta a scopi elettorali), di non opporsi ad una legislazione iper-garantistica e di accettare l’occupazione partitica dell’apparato dello Stato. Con questo si rinunciava ad educare la gente ai valori dell’intraprendenza personale e del libero mercato, si apriva la strada all’orgia dirigistica e parassitaria che avrebbe dilagato dopo il 1969, e si metteva mano ad un sistema legislativo e contrattuale implacabilmente divergente da quanto il resto del mondo andava costruendo.
La legge del 20 maggio 1970, chiamata Statuto dei Lavoratori, creò un generale condizionamento scollegato da ogni logica di efficienza e produttività, e da ogni contributo al benessere collettivo. Gli imprenditori non soltanto accettarono di fare gli esattori per conto dello Stato, in modo che i lavoratori non conoscessero quanta parte del loro compenso era prelevata dallo Stato medesimo sotto forma dei cosiddetti “oneri sociali” e delle tasse, ma anche di fare i collettori per le quote da pagare ai sindacati.
Rimase la “scala mobile”, un istituto di emergenza del tempo di guerra, Italia unico paese al mondo ad averla in tempo di pace, con conseguenze nefaste in tempi di grande inflazione.
E rimase il contratto di lavoro negoziato e firmato su base nazionale, modalità che fece più danni, soprattutto al Sud dell’Italia, di qualsiasi altra istituzione, non avendo alcuna motivazione oggettiva, svincolata com’era da qualsiasi connessione con la competitività industriale e giustificata soltanto dalla volontà di lasciare un immenso potere nelle mani delle strutture burocratiche del sindacato centrale, peraltro sempre più avulso da logiche economiche.
Su quella lunghezza d’onda vennero messe in atto ciniche prassi, come quella delle aziende private che pagavano “a babbo morto” i fornitori, con le banche che “scontavano” a caro prezzo le fatture (un istituto esclusivamente italiano), pur di non immettere capitale fresco a sostegno della loro crescita, in sintonia con uno Stato che pagava i servizi ricevuti in ritardo, sovente dietro corresponsione di tangenti ai funzionari e/o ai partiti.
Se non si pone il pensiero e l’opera di Adriano Olivetti nel contesto che ho succintamente delineato, si rischia di non capire la portata di quelle che fece e, ancor più, di quello che avrebbe voluto fare e la morte prematura gli impedì di fare; e che l’oligarchia economico-politica del Paese, che si andava sintonizzando su altre lunghezze d’onda, non aveva nessuna intenzione di lasciarlo fare.
Credo proprio che lui fosse cosciente di quello che stava accadendo sul piano sociale come conseguenza dell’industrializzazione, e che, con la stessa lungimiranza che aveva messo a promuovere l’elettronica, cercasse di indirizzare i profitti che l’Azienda gli metteva in tasca verso un’evoluzione di politica sociale progressista sul serio, concreta, né ideologica né conflittuale, sensibile ai bisogni locali e radicata sul territorio. Se questa analisi è vera non può che essere ammirata la strada immaginata da Adriano Olivetti, e deprecata la sua solitudine e, alla fine, la sua sconfitta.
Resta la storia: per motivi diversi, l’establishment finanziario/industriale del Paese, e, ancor più critico, quello politico/sindacale, non furono mai in sintonia con Adriano, e i guai dell’Olivetti che arrivarono nella prima metà degli anni 1960, costringendola a rinunciare alle sue ambizioni nell’elettronica e nello sviluppo internazionale, non giunsero così spiacevoli per l’oligarchia dominante come lo furono per chi in Olivetti ci lavorava, a Ivrea come a Pregnana.
Dopo il 1969, politici spregiudicati e sindacalisti inesperti o parassitari avrebbero cavalcato un attacco lento ma implacabile contro tutte le entità del Paese che conservavano una loro etica ed una loro prestanza.
D’altro lato le forze della conservazione finanziaria avrebbero approfittato della situazione per impedire che la crescita dell’economia globale, la partecipazione civile e le regole di un mercato avanzato mettessero in crisi i privilegi dell’eredità e della speculazione. Difficile opporsi a quella tenaglia di largo respiro. Le basi del benessere italiano erano state costruite negli anni 1950 e 1960 come somma di sforzi collettivi, dei grandi come dei piccoli, imprenditori, manager e lavoratori. Non un miracolo, ma un’epopea.
Le posizioni delle grandi imprese vennero erose negli anni 1970 e 1980, mentre ancora i piccoli imprenditori privati riuscivano ad esprime nuove volontà, ma a partire dagli anni 1990 divenne impossibile pensare a nuove costruzioni e gli anni 2000 avrebbero segnato il generale collasso.
Ancora peggio: era l'”etica del capitalismo” del nostro Paese che sarebbe stata corrotta dalle forze maligne e sarebbe stato impossibile ricostruirne una nuova. Dopo i costruttivi anni 1960, a partire dal 1969 la mia intera vita di lavoro si sarebbe trovata a navigare in quella storica involuzione e sovente mi venne di pensare ad Adriano Olivetti ed alla sua “terza via”.
[testo tratto dal libro “Quando in Italia si facevano i computer” di Giorgio Garuzzo, e-book, 2015]
Sullo stesso argomento leggi anche: “Ricostruzione dopo il coronavirus come il dopo guerra? Adriano Olivetti“