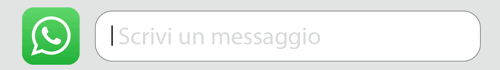Divagazioni su “La casa dei ricchi” di Carlo Emilio Gadda.

Ho per le mani il libricino edito qualche mese fa da Adelphi La casa dei ricchi di Carlo Emilio Gadda, trattamento per il cinema del suo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Nel 1948 le “miserrime configurazioni argentine” (così lui chiama le sue difficoltà economiche) lo spingono ad accettare la proposta della Lux Film di ricavare una sceneggiatura dal suo romanzo che la rivista Letteratura stava pubblicando a pintate(ne erano, al momento, uscite solo cinque).
Nasce così il Palazzo degli ori: questo il titolo che Gadda diede al primo trattamento, che ebbe – come era nella natura e nella creatività dello scrittore – un complesso e travagliato cammino di scrittura.
La società cinematografica – sia pur guidata da un raffinato intellettuale, il musicologo Guido Maggiorino Gatti – non era affatto soddisfatta dello scritto che (in varie puntate e con vari ripensamenti) arrivava ai suoi lettori: la struttura del romanzo e, di conseguenza, del trattamento cinematografico, era troppo complessa, con troppi personaggi e sottotrame e, soprattutto, non era così linearmente inserita nel plot la scoperta dell’assassina.

D’altronde, il povero Gadda non era certo un giallista (anche se notoriamente amava il genere) e non a caso nel romanzo (uscito nel 1957) il whodunit – come si chiama la scoperta del colpevole in gergo – è appena accennato (lo scrittore aveva promesso all’editore Livio Garzanti un sequel chiarificatore che non vide mai la luce).
Questa apparente anomalia non era certo estranea nella produzione di Gadda, così splendidamente intenso nell’accompagnare il lettore nei meandri della proprie ansie narrative ed emotive da, quasi, non tollerare che le vicende narrate si facessero cronaca spicciola. Di fatto anche nel suo capolavoro (comunque il suo testo più personale e sofferto), La cognizione del dolore non sapremo mai davvero se abbiamo letto di un matricidio o solo di una fantasia, nata dall’amore totalmente pervasivo e denso di oscure angosce del protagonista per la madre. E, in fondo, non importa: c’è lì tutto il Gadda ironico, dolente e fantastico nel ricreare immagini, suoni e neologismi, che rendono cupamente immaginifico anche il linguaggio più crudamente quotidiano.
La Lux gli chiese di ridurre ad un quarto il corposo trattamento e di semplificarne il plot. Nacque così La casa dei ricchi che in 40 scene scarnifica e riassume la trame del romanzo, con il commissario Ingravallo che (a differenza del romanzo) raggiunge in Sardegna l’assassina (la cameriera Virginia che ha ucciso la padrona Liliana per sostituirsi a lei) mentre sta per strangolare la vecchia nonna.
Non se ne fece niente e nel ’59 il produttore Peppino Amato – pressoché analfabeta ma di sicuro istinto – acquisì i diritti del libro e convinse Pietro Germi a dirigere il film, che nel ’59 uscì con il titolo Un maledetto imbroglio, il più bel poliziesco della storia del cinema italiano e, praticamente, un film perfetto (ai tempi fu accolto con sussiegosa benevolenza dalla critica – allora quasi tutta comunista – che non concedeva granché al “saragattiano” Germi).

La storia del romanzo vede il commissario Ingravallo indagare su di un furto nella casa al centro di Roma di una stramba signora, che frequentava ambigui giovinastri e, dopo una settimana, sull’omicidio a scopo di rapina della religiosissima signora Liliana nello stesso stabile. Le due indagini parallele, nel romanzo, avranno pochi elementi di contatto ma il racconto sviluppa tutto il sarcastico disprezzo che Gadda provava per la corrotta e sorniona borghesia e, in fondo, per le donne di quel ceto, conniventi, nella sua visione (vedi Eros e Priapo), con le peggiori storture della società.
Germi.- insieme ai co-sceneggiatori Alfredo Giannetti e Ennio De Concini – ne asciuga trama e personaggi (ad es. la prima rapina vede come vittima il vicino gay che nel romanzo era un testimone reticente) e cambia completamente il finale: l’assassino è uno dei gigolò che circolavano nel palazzo e che, pentito, ha sposato l’ultima cameriera di Liliana, sua complice nel furto finito male (ma il commissario lascerà andare la ragazza – una indimenticabile Claudia Cardinale – impietosito della sua gravidanza).
La babelica – quasi atonale – confusione di persone, situazioni e lessico, che fa di Gadda uno dei maggiori letterati italiani del secolo scorso, nel film si sistema in bozzetti, nel tono tra l’ironico, l’indignato e il teneramente sarcastico che sarà alla base del suo splendido Signore & signori del 1966.
Il libricino ci consente così una riflessione sui rapporti tra il cinema e la letteratura. Si è sempre sostenuto che gli scrittori sono i peggiori sceneggiatori delle proprie opere e se ne capisce anche il perché: da un lato la scrittura letteraria e la sceneggiatura sono molto diverse tra loro, dall’altro, l’autore non potrà non difendere la propria creatura dalle semplificazioni e dagli stravolgimenti della riduzione cinematografica.
Esistono sempre delle eccezioni: una è senz’altro la serie televisiva Montalbano ma Camilleri nasce scrittore televisivo e i suoi romanzi – tutti successivi a quell’esperienza – sono già, nei fatti, delle sceneggiature.
Da Un maledetto imbroglio ci viene invece una conferma: Germi (che del romanzo aveva letto solo metà, annoiato dai suoi funambolismi linguistici) rifuggiva come la peste le – per sua fortuna rare – incursioni di Gadda sul set ma lo scrittore, quando vide il film, lo apprezzò moltissimo, considerandolo – come era – un bellissimo poliziesco più che la riduzione della sua opera.
Tutto nel film farà epoca: l’essere stato il primo – mai raggiunto – esempio di vero polar italiano, il cast perfetto, la cruda ed avvolgente fotografia di Leonida Barboni e, non ultima, la bellissima canzone Sinnò me moro che Carlo Rustichelli affida alla figlia sedicenne Alida Chelli e che segnerà un svolta epocale nella tradizione della canzone romana.
Solo nel ’96 avremo una riduzione fedele del Pasticciaccio: Ronconi firma la sua ultima regia teatrale con un operazione, che per molti versi, ci riporta al suo Orlando Furioso, restituendo il mosaico linguistico ed umano del romanzo con un cast pieno di grandi attori (compreso un giovanissimo Favino).
Ma appunto, era teatro.