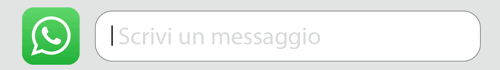Sono quarant’anni che l’Irpinia ricorda, ogni anno, con immutata (e comprensibile) commozione i giorni tremendi del terremoto che, il 23 novembre 1980, distrusse larga parte del suo territorio, pezzi di Basilicata e seminò il panico fino a Napoli. E con esso ricorda la devastazione successiva che fu quasi peggiore, nei suoi effetti sociali, del sisma stesso. Ma a una rapida rassegna delle voci che affollano gli appuntamenti del 23 novembre, e dei giorni a ridosso, è evidente che sono, tutto sommato, sempre le stesse e vanno riproponendo argomenti costanti nel tempo.
Gli errori della ricostruzione. La classe politica inadeguata. La mancanza di programmazione che ha fatto sfumare “l’occasione” dello sviluppo. Come se per costruire il futuro di una comunità ci sia bisogno di una catastrofe da migliaia di vittime, il cui impagabile prezzo di sangue si immagina possa quantificarsi in miliardi di fondi pubblici.
Soldi riversati, a pioggia, nelle tasche di chi è rimasto e ha usato un apocalittico lutto collettivo per costruire le proprie fortune, ipocritamente benedette dalle lacrime del cordoglio. Uno spirito che ha giustificato gli sprechi che hanno offeso non solo la memoria dei morti, ma il Paese intero.
Subito dopo, è arrivata quella che si definisce la “generazione delle macerie”. Gli irpini nati (come chi scrive) dopo il 23 novembre 1980 e che pur non avendo sentito la terra tremare se ne sentono ugualmente vittime, avendo subito da quegli eventi un “furto di futuro”. Come se prima del terremoto la Campania interna avesse davanti a sé un fulgido avvenire di prosperità, quando l’emorragia di braccia e teste verso il Nord d’Italia e l’estero era in atto già da tempo.
Lo “spopolamento”, prima delle montagne del cratere e poi dell’intera provincia, senza il sisma si sarebbe consumato molto prima. La droga della ricostruzione ha avuto due effetti principali. Ha prodotto uno stato di eccitazione collettiva che, per circa un trentennio, ha convinto gli irpini di essere al cuore di un nevralgico centro politico e culturale. Ha ritardato un processo di svuotamento che interessa da decenni tutta l’Italia “interna”. Dalle Alpi all’Appennino, fino ai più piccoli centri costieri, in particolare meridionali. Un fenomeno che ha matrici molto complesse, da ricercarsi nel processo di concentrazione di ricchezze e capitali su cui si fonda l’economia globalizzata, che non è il caso qui di analizzare.
Quello che invece è interessante osservare, quarant’anni dopo la catastrofe, è il linguaggio che normalmente si utilizza per parlare degli eventi naturali che mettono in discussione l’ordine artificiale creato dall’uomo per piegare l’ambiente circostante ai propri bisogni.
Questo quarantesimo anniversario, infatti, cade significativamente nell’anno di una nuova pandemia. Come in altri momenti della storia, le società umane sono messe a dura prova dalla necessità che la natura ha di riequilibrare i rapporti di forza tra le parti.
In questa congiuntura, il linguaggio con cui trattiamo eventi che sono esattamente nell’ordine delle cose è lo stesso utilizzato per parlare di conflitti. Il virus è il nemico e dunque, per definizione, “cattivo”. Per consentire alle nostre menti di comprendere e razionalizzare fatti imprevisti e incontenibili, abbiamo bisogno di decodificarli attribuendo loro una volontà malevola analoga a quella che è alla base delle guerre.
Pur non avendo con esse nulla in comune. Le guerre sono indotte da desideri di dominio e sopraffazione. A differenza delle epidemie. Delle alluvioni. Dei terremoti. La natura semplicemente sta, vive e si trasforma. Prescinde dall’essere umano, che è una delle tante specie che della terra vivono e si nutrono. Eppure noi le attribuiamo una volontà ostile che non le appartiene. Perciò raccontiamo i terremoti e le altre catastrofi come se traessero origine da un piano sovraordinato volto a ferire quella data comunità, il suo territorio e il suo ordine. È una comprensibile ricerca di senso, che produce simboli per la rielaborazione del lutto, della separazione, della distruzione. Eventi che, in sé, la mente umana non riesce a contenere.
L’insidia sta nella funzione legittimante che questi processi collettivi finiscono per svolgere. Davanti alla furia del nemico, infatti, bisogna reagire. Tornare a vivere. Ricostruire. Come se un virus o una calamità fossero un’armata straniera da scacciare.
Nel caso del terremoto dell’Irpinia tutto ciò si trasformato nell’innesco di una foga generalizzata che, drogata appunto dai denari della ricostruzione, ha mortalmente alterato il senso della realtà. Ha prolungato un’illusoria agonia e allontanato di qualche decennio un epilogo già scritto, in assenza di scelte politiche all’altezza. Puntualmente mancate per l’incapacità di leggere congiunture politico-economiche che vanno ben al di là beghe interne alla Democrazia cristiana locale o al malaffare. Purtroppo.
Ecco perché è insufficiente la retorica del furto di futuro legato al terremoto del 1980. Quel furto era già in atto, per mano di quanti sono stati poi riconosciuti come i responsabili dell'”occasione mancata” della ricostruzione. Come se la morte possa essere un’opportunità. La morte non è mai un’opportunità: nulla può porvi rimedio. Nemmeno i miliardi di una ricostruzione. Può esserlo solo per chi resta e usa la tragedia, e il bisogno naturale di superarla, come mezzo per crearsi una posizione di potere. Politico. Economico. Intellettuale.
Per questo la generazione dei nati subito prima o dopo il 1980 continua a fallire come quelle che l’hanno preceduta. Pur dichiarando di volerne prendere le distanze, ne abbiamo ereditato gli atteggiamenti autoreferenziali e una lettura parziale della realtà. Ignoriamo la lunga durata storica in cui quella frattura, dolorosissima, si innesta. Un’appropriazione indebita di quel dolore che non fa altro che renderlo più acre.
L’onestà intellettuale sarebbe il miglior modo di commemorare le vittime. Imparare a leggere quello che è stato e fare un uso attento della memoria per non trasformarla in uno sterile strumento di rivendicazione. Anche perché di retorica dell’emergenza e della ricostruzione l’Irpinia ha finito per morire.
Non esiste un’anagrafe delle case post-terremoto e dei loro occupanti. Non esiste un censimento coordinato dei bisogni socio-abitativi del territorio. Non si comprende nemmeno più quale sia la reale consistenza della platea degli ex-articoli 21: gli “sfollati” aventi diritto a una casa. Dopo quarant’anni tutto continua a essere emergenza. Nella sola città di Avellino si continuano a costruire alloggi popolari senza riuscire a ultimarli e riempirli. Si progettano ancora interventi di riqualificazione. Si immaginano nuovi cantieri ancora di prima di chiuderne altri che non hanno più età. E nessuno dimostra di avere la minima idea di quale possa essere il futuro di un territorio che, come tanti altri, la globalizzazione sta spingendo ai margini.
Il terremoto ha finito per diventare un alibi per l’incapacità generale. Bisogna ammetterlo per rispetto di chi non c’è più e di chi, quel 23 novembre, ha davvero perso il senso della propria esistenza. La memoria è un’altra cosa.