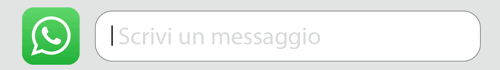«Sono stanco Giulia. Stanco. Dormo e aspetto. Non faccio niente. Non c’è niente da fare». Solomon è nigeriano. Ha 23 anni. Ma il suo corpo, piccolo e nerboruto, ne dimostra di più. La sua voce al telefono esprime la gioia di un affetto ritrovato, ma è colma di tutta l’esasperata stanchezza che tenta di comunicare in parole. Solomon è uno di quei tanti “clandestini vacanzieri” la cui vita si è fermata da quando è arrivato in Italia. Una vita sospesa nel vuoto. Ferma. A vent’anni.
A vent’anni non avere un presente e non vedere un futuro. Poter raccontare, a fatica e con nostalgica sofferenza, solo il passato. A vent’anni. Non essere più nessuno, oggi, dopo che si è stati tante cose, ieri. A vent’anni esser capace di cucire 20 jeans al giorno e saper realizzare abiti e kaftani, a occhio, senza prender misure. Avere una forza fisica dirompente e doverla abbandonare all’inerzia di un’attesa che ha già ucciso tutti i sogni. A vent’anni. Sapere che non si diventerà mai sarti perché sarà già tanto avere i documenti per cercare un lavoro qualsiasi.
Non è buonismo. Non è pietismo. È la realtà. Non è propaganda per Carola Rackete e nemmeno per la ong Mediterranea. Queste cose non c’entrano nulla. Sono solo una parte del problema per come lo vedono gli europei. I bianchi. Un dibattito che a un migrante in mare non interessa e che addirittura ignora quando tende le braccia cercando aiuto.
Anzi: quando Solomon è arrivato in Sicilia non esistevano né l’una né l’altra. Quella di Solomon è una delle centinaia di storie che non appartengono più a nessuno se non alla burocrazia italiana. Alle leggi sull’immigrazione che ogni governo modifica rendendole sempre più aspre e confuse. Ottenendo come uno risultato il peggioramento dello stato di ansia e disperazione di tanti giovani che hanno in sé una enorme responsabilità. Una famiglia, un intero villaggio che li chiama, li cerca perché mandino a casa i soldi. Perché sul loro viaggio hanno investito. Tutti. E spiegare che in Italia, in Europa è difficile, non c’è lavoro, non lo si può cercare, non è cosa facile. Al di là del Sahara è impossibile pensare che Solomon, Mohamadou o Femi non riescano a trovare lavoro a circolare per cercarlo. Loro sono in Europa. Da un lato la burocrazia, le lotte della politica giocate sulla loro pelle. Dall’altro le terre di origine che pressano perché lo sforzo collettivo porti frutti. Nel mezzo ci sono loro. A vent’anni o poco più. Ripenso a me a vent’anni o a mia sorella oggi e non riesco a immaginarmi con la responsabilità di dover sfamare mia madre o i miei vicini di casa.
È vero: non sono “profughi”. Non tutti. Molti non sono niente altro che giovanissimi con un sogno che diventa ben presto una responsabilità sociale enorme. Uscire dalla povertà portando con sé interi nuclei familiari che su viaggio verso Nord hanno investito. Nulla a che vedere con le immagini di cellulari, barboncini e ciabattine da mare che ci martellano per alimentare il nostro stadio di assedio.
Dentro i centri di accoglienza, oltre le reti contro cui si vedono assiepati i sorrisi beffardi dei “giovanotti in piena salute” di cui parla Matteo Salvini, c’è questo. E tutto questo va raccontato oggi, ancora di più, perché la partita, tutta politica, delle autorizzazioni a procedere, o degli zerovirgola nei sondaggi elettorali, si gioca su questo. Al netto delle teste calde. Di chi è emigrato seguendo il flusso senza sapere di preciso cosa sarebbe accaduto dopo. Nessuno lo sa. Eppure si parte. Perché al di là dal mare c’è un sogno, una speranza che fa presto a diventare prima delusione. E poi disperazione. Chi conosce la vita nei centri di accoglienza sparsi per il Paese, lontani dal clamore mediatico degli hub siciliani sa che contengono tutto questo. E molto altro.
La cosa che accomuna tutti è l’attesa. L’attesa del responso della commissione. Che impiega mesi. Molto più di quelli che la legge impone. E poi il ricorso. E poi il decreto di espulsione. Che nessuno attua. Perché non ci sono i soldi. Né gli accordi. E quando un dinegato (un migrante che non si è vista riconosciuta alcuna forma di protezione internazionale) viene messo alla porta dagli operatori, semplicemente smette di esistere: per lo Stato italiano e per l’Europa. Non ha un passaporto che gli consenta di tornare a casa. E non ha i soldi per farlo. O per sopravvivere. E comunque il ritorno a casa sarebbe una vergogna insopportabile. Senza documenti non può trovare lavoro. Ma senza lavoro non può richiedere i documenti.

A queste condizioni non è difficile immaginare che le sole porte che riesca a aprire sono quelle della strada. E dell’illegalità. Non è un romanzo. È la semplice, lineare e cruda realtà. Quella che alimenta le schiere della prostituzione e del bracciantato irregolare, magari al soldo di caporali, a Foggia come a Saluzzo, nel civilissimo Piemonte. È tutto frutto di una questione burocratica e di leggi idiote che creano tunnel senza uscita. Nell’illusione che qualcuno, un ministro, un “premier”, un decreto legge o un testo unico, possano fermare la spinta della fame. Che poi diventa speranza alla fine naufraga nel mare della disperazione. E dell’alienazione.
Questo vuol dire lo slogan: “Nessun essere umano è illegale”.
Le immagini dell’articolo sono di Simonetta Prestinenzi e Martina Ferramenta che hanno volontariamente prestato la loro opera fotografica per il progetto “I sarti neri” finanziato dalla Caritas di Avellino
La modella è la giovane Rossella Gomes che ha accettato di posare, gratuitamente, indossando alcuni abiti dei Sarti Neri