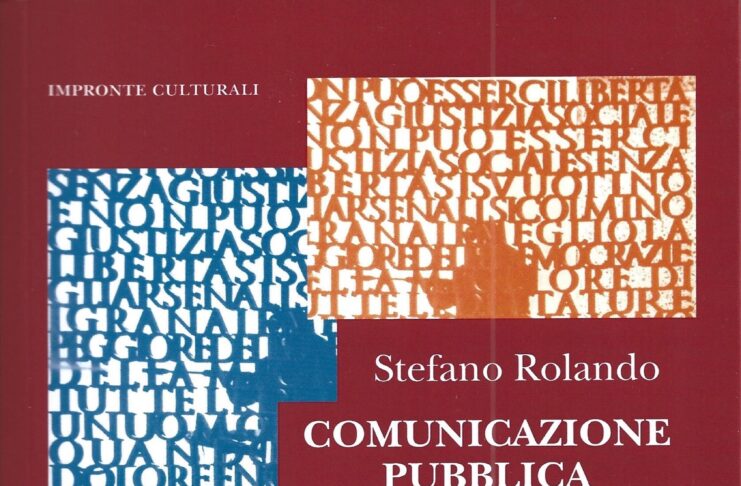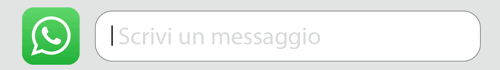Caro Stefano Rolando, questa volta non sei tu che scrivi o intervisti, come fai da tempo e con tanti contributi anche su questo giornale. Ma è questo giornale che intervista te. Perché è uscito un tuo libro che ha un titolo importante, che ci interessa e che fa una proposta da capire. E perché nei prossimi giorni (il 15 dicembre, per iniziativa del Comitato scientifico dell’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale) di questo libro se ne parlerà addirittura al CNEL, una istituzione di mediazione tra società, politica ed economia.
Grazie molte davvero. Da dove cominciamo: dal titolo e dalla proposta da capire?
Benissimo. Allora: perché il titolo e quale è la proposta?
Il titolo paragona – proprio in questo momento – la comunicazione pubblica (che non è più il messaggio verticale dal potere al popolo, ma è il messaggio circolare che va e torna tra istituzioni e società) al “teatro civile”. Che è una sorta di rappresentazione fatta per sostenere gli interessi generali, non quelli di una parte, sia essa politica o sociale o finanziaria. E la proposta che sta nel sottotitolo è che è venuto il momento, soprattutto quando ancora la pandemia morde ma è meglio contrastata, di lavorare a una riforma della comunicazione pubblica. Per un obiettivo principale (poi ce ne sono molti altri, anche) che io identifico nel “governo della spiegazione”.

Andiamo per ordine. Perché in questa “copertina” prevale la parola “spiegazione”?
Perché è la cosa su cui c’è più domanda e su cui c’è meno offerta in un momento storico in cui su questo “mercato”, se le cose andassero diversamente, avremmo più speranze di organizzare meglio il nostro futuro. La domanda di spiegazione deve ridurre l’eccesso di analfabeti funzionali e di ritorno che da noi sono un peso grave che produce confusione, vaghezze, populismi, abbassamento della soglia della comprensione dei problemi. E’ una domanda rivolta non solo a ministeri e assessorati. Ma a tutto il quadro pubblico e di pubblico servizio: dalla sanità alla scuola, dalla gestione dell’ambiente ai servizi alla persona, dalla sicurezza al servizio pubblico radiotelevisivo. Proviamo a immaginare che concreta alleanza sarebbe possibile se si volesse davvero “governare la spiegazione”!
Spiegazione di che?
Siamo pieni di informazioni su fatti ed eventi, ma poveri di racconti che interpretino i nessi tra le cose, cioè che spieghino i processi. Un “processo” è un’epidemia, è una riforma, è un progetto per evitare alluvioni e terremoti. Un processo è un tentativo di ridurre le disuguaglianze, di ampliare il mercato del lavoro, di capire se i prezzi sono giusti o sbagliati. Se capisci il senso delle cose puoi giudicare la tua vita, quella degli altri e la natura delle decisioni. Altrimenti dai sempre ragione all’ultimo che ha parlato. E quando accadono i fatti finisce che non distingui mai bene ciò che è vero da ciò che è falso.
Ma che cosa ha prodotto questa situazione?
Questa situazione riguarda la metà della condizione sociale generale. Un’enormità. Da una parte sarà anche interesse di un certo potere (non di tutti i poteri) mantenere questo stato di cose. Ma le cose sono anche peggiorate perché finora la rivoluzione digitale – che ci ha dato molte opportunità, molte velocità, molte risposte – ha anche marginalizzato le mediazioni professionali al suo trattamento e agito per confondere le cose buone da quelle marce. Metà di noi non ci casca, l’altra metà non solo ci casca ma le amplifica. Il popolo no-vax (per quanto io stesso ho potuto più volte ascoltare) ha una sola bibbia: “sta nella rete”. Così come cinquanta anni fa dicevano: “l’ha detto la televisione”. E qui delle due l’una: o si imbocca la via autoritaria di controllare e censurare la rete; o si rispetta l’evoluzione di questo mercato alzando la soglia di salvaguardia cognitiva e critica dei cittadini. Un immenso progetto degno dell’Europa e di paesi davvero democratici.
Ma l’indipendenza del sistema mediatico non basterebbe da sola ad affrontare questo problema?
La libertà e l’autonomia dei media è un punto base rilevante. Ma la regola dei media resta – tra la marea di news che lo attraversa e le superfici singolarmente limitate che le selezionano – legato all’idea che sia la cattiva notizia a fare notizia. Nessun può imporre per legge una gerarchia dell’informazione. Quello che si può fare è avere una politica delle istituzioni perché operino non per favorire le “buone notizie”, per carità, e nemmeno per parlare bene si sé stesse. Questo lo abbiamo già visto con i regimi dittatoriali. Ma per aiutare a portare in agenda le notizie davvero utili al processo partecipativo e per potere fare di ciascuno un buon pescatore di strumenti utili a capire. Capire per vivere meglio e per migliorare integrazione e coesione sociale.
Siamo in epoca di politiche di transizione. Tra cui la “transizione digitale”. In questa cornice ci può essere una accelerazione interessante e compatibile con gli argomenti qui esposti?
Non c’è dubbio. Ci sono alcune macro-trasversalità che rendono possibile non solo l’accelerazione, ma anche l’organizzazione qualitativa e quantitativa di un simile processo. Oltre a migliorare linguaggi, soluzioni, accessi. Ho visto proprio in questi giorni il lancio di un nuovo manuale, curato da amici competenti, che offre una panoramica vasta di azioni che sono tutte da implementare – se non addirittura da radicare in molti contesti – nel tessuto che resta ancora precario digitalmente dei nostri settori pubblici. Pur con passi avanti evidenti. Resto dell’idea che questa tematica – rilevante come il rinnovamento della formazione, come l’europeizzazione delle esperienze e dei principi ispiratori, come la promozione normativa di alleanze sussidiarie – non debba essere scambiata con il fine ultimo di una riforma della comunicazione pubblica, che deve essere “sociale” più che “social”. In ogni caso l’annuncio recente del ministro Colao circa il 75% della PA sul cloud entro il 2026 comporta un forte cantiere di performazione generale che coinvolge certamente le attività di comunicazione (interna ed esterna).
Per affrontare obiettivi così ampi e trasversali basta una riforma “comunicativa”?
Se ti rispondo di sì, non dico la verità ma mantengo un po’ di forza per negoziare questo obiettivo. Se ti rispondo di no, dico la verità ma l’elenco diventa così lungo (ho fatto prima qualche esempio) da indebolire del tutto il mio obiettivo. Mi limito dunque a una cosa di tutta evidenza. Se non si mette mano almeno alla revisione strategica della scuola, manca una parte essenziale per dare il contesto giusto a un percorso di efficacia della comunicazione pubblica. In ogni caso segnalo che il titolo della prefazione di De Rita risponde a un altro aspetto della domanda: “Se non ora, quando?”.
Molti anni fa tu stesso hai lavorato in questo campo, nelle strutture di vertice del governo, per avviare il radicamento della comunicazione pubblica in Italia e in Europa. Cosa avete conseguito? Perché si sono accumulati nuovi problemi?
Abbiamo operato nel decennio prima di internet. Eravamo in epoca di pre-condizioni. Bisognava dimostrare (facendo e legiferando) che la regola del silenzio & segreto che dominava la cultura della P.A. ci portava alla rovina democratica. E che essa andava sostituita dalla trasparenza e dall’accesso. A me diedero il compito di mostrare nei fatti che si poteva fare. Poi, dopo cinque anni di “fatti”, arrivò la legge 241 del 1990 a sancirlo. E lì cominciò un secondo tempo in cui si fecero balzi avanti. E ci si aprì alle esperienze europee. Poi la crisi della politica, poi la fine di un ciclo che ci portò in un sistema in cui il rapporto tra politica e istituzioni fu sempre più basato sull’idea della visibilità e non delle riforme possibili. Il risultato è arrivato negli ultimi anni in modo catastrofico.
“Catastrofico” vuol dire che non si produce più? O che nessuno sa fare più niente? O che si delega tutto ai media?
Catastrofico vuol dire che, a poco a poco, la comunicazione politica ha occupato gli spazi che avrebbero dovuto essere riservati a operatori capaci di gestire un servizio pubblico delicato e complesso. Per il quale la legge 150 del 2000 (che arrivò sei anni dopo che l’avevamo immaginata e richiesta) ha almeno disegnato buone finalità e un indirizzo di base che tiene salvo quel principio. Certo è nata in una condizione di cultura digitale acerba. Molto si potrebbe fare per creare condizioni di aggiornamento. Ma attenzione. Quando dico che la comunicazione che fanno le istituzioni è oggi troppo asservita alla politica vuol dire che prima bisogna tagliare questo stato di occupazione. Complice anche l’eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, ecco che a livello nazionale, regionale e locale negli spazi previsti per fare servizio ai cittadini si sono spesso installati gladiatori digitali per fare, a spese dei contribuenti, squadrismo e propaganda. Non dico dappertutto sia chiaro. Ma il caso della Bestia al Ministero dell’Interno o del factotum Casalino a Palazzo Chigi – tutti votati a confezionare consenso per i loro capi – non sono certo isolati. Ovvero solo di una parte politica.
Di che cosa dovrebbero oggi occuparsi quei servizi?
Basta fare un giro tra i paesi europei che sanno distinguere ancora politica e istituzioni e che rispettano la capacità negoziale del cittadino. La comunicazione pubblica è cresciuta anche attraverso l’affermarsi dei suoi specialismi. La comunicazione di crisi ed emergenza è dappertutto, noi l’abbiamo rifilata solo alla protezione civile. Il contrasto alle fake news è prezioso nell’interesse dello stato e della società. Schiere intere di operatori per aiutare a smascherare. La public diplomacy agisce nel quadro delle relazioni internazionali. Il public branding agisce su identità e attrattività. Potrei elencare di più. Tutto il sistema euro-mediterraneo ha sviluppato specializzazione importante nel campo migratorio, meno che da noi perché sulle migrazioni siamo rimasti allo scontro tra respingerli o chiuderli in campi provvisori. Ora a fronte della pandemia in atto si tratta di salvare anche la lezione di una crescita di comunicazione scientifica indispensabile da riorganizzare capillarmente. Eccetera, eccetera.
Di tutto ciò che c’è nel tuo libro?
Ci sono i contributi recenti scritti per creare un necessario dibattito pubblico per rettificare l’idea che tutto resti come prima. O che basti mettere un ministero su Instagram per salvargli la mission e l’esercizio sociale delle competenze. L’università è stata il laboratorio di una attenzione critica permanente. Ma essere rimasto presidente della rete europea degli operatori di comunicazione istituzionale (il Club di Venezia, che agisce informalmente ma che è radicato nel quadro istituzionale UE, che fondammo a metà degli anni ’80 e che – dico per inciso – ha la sua sessione annuale proprio a Venezia in questi giorni) mi offre un quadro esemplare di disparità rispetto alla situazione italiana, purtroppo scappata di mano. Ci sono ancora situazioni di corretto funzionamento. Ci sono molti giovani che ricevono un’idea giusta dalla preparazione di base che ora è un po’ meglio che trenta anni fa. C’è una domanda grande come una casa. E per dirla con la prefazione che Giuseppe De Rita ha scritto con riferimento al quadro attuale di governo: “se non ora, quando?”.
Ma come va interpretato il tema di “una riforma possibile”? Come una nuova legge?
Ormai la parola “riforma” copre qualunque “cambiamento normativo”. E “fare leggi” sembra essere l’unico modo di incidere sugli apparati pubblici che non hanno grande tradizione di common law in Italia. Il punto è che non si coglie più esattamente quale sia l’ambito istituzionale – che pur ci sarebbe e comunque ci dovrebbe essere – in grado di fare cabina di regia. E già chiarire questo punto sarebbe una “riforma”. Poi si potrebbero studiare alcune proposte di articolazione di funzioni attorno allo sviluppo di programmi permanenti di “spiegazione”. E anche questo – persino senza fare una legge – sarebbe rivoluzionario. E infine servirebbe un grande laboratorio di apprendimenti e buone pratiche ben più moderno del vecchio modo di fare lezioni frontali di formazione professionale. Ecco, una volta che ciò fosse autorevolmente tentato e governato, connettendosi con la spinta alla transizione tecnologica già in atto, resterebbe da vedere cosa manca per imbarcarsi veramente nell’iter legislativo, che l’ultima volta sulla materia è durato sei anni. Un tempo ormai inaccettabile per incidere su questa materia.
In cosa consiste l’incontro previsto al CNEL il 15 dicembre?
In una illustrazione e discussione delle argomentazioni qui esposte in sintesi, per iniziativa – come hai ricordato all’inizio – del presidente del comitato scientifico della Associazione italiana di comunicazione pubblica, Piervirgilio Dastoli, credo in prima istanza all’ampio gruppo di esperti e docenti che quel comitato esprime. Darà un suo contributo anche Giuseppe De Rita, presidente del Censis e già presidente del CNEL, che fu all’origine del rapporto nazionale sullo stato della comunicazione pubblica in Italia che realizzai nel 1995, nella fase di avvio di elaborazione di quella che poi diventerà la legge 150, che tuttora governa il settore. Ma che, in molti suoi interventi, torna spesso sulla relazione tra istituzioni e società, tema di guida per orientare una materia che deve comunque guardarsi sempre dai rischi dell’autoreferenzialità.
Stefano Rolando insegna “Comunicazione pubblica e politica” all’Università IULM di Milano (di ruolo dal 2001 al 2018). Nel quadro di una articolata esperienza precedente di management in istituzioni e imprese è stato per 10 anni d.g. e capo Dipartimento informazione ed editoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, contribuendo largamente all’avviamento della comunicazione pubblica dell’età democratica e repubblicana in Italia e in Europa, anche come presidente del “Club of Venice”, rete dei responsabili della comunicazione istituzionale dei paesi membri e delle istituzioni UE.