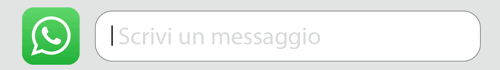Dopo sei mesi di lettura, analisi e scrittura a tempo pieno in materia di comunicazione e crisi sanitaria (il monitoraggio universitario quotidiano che mi ha portato a due libri ora in uscita), il destino mi ha acchiappato per il colletto proponendomi una piccola esperienza personale, che vorrei qui trattare senza polemiche, senza rivendicazioni, ma con qualche elemento di valore aggiunto rispetto ad un tema che seguo da molto tempo, considerandolo civilmente e democraticamente cruciale: la comunicazione sanitaria, intesa come rapporto tra medicina e società, tra operatori e pazienti.
Premetto che tutto lo sguardo alla situazione in corso – prevenzione, contrasto, terapia – su Coronavirus è orientato a una certa ammirazione per l’abnegazione di medici e infermieri e che credo che, in generale, il “caso italiano” non sia rubricabile nel “libro nero”. Di punti di domanda ce ne sono tanti (la qualità statistica, la crisi della medicina territoriale, i casi di sottovalutazione, un certo paternalismo di stato, i ritardi, eccetera, argomento che tratto nel libro in uscita “Pandemia, laboratorio di comunicazione pubblica”, Editoriale scientifica). Ma quando si vede di persona, ci si fanno altre domande. Eccole.
Torno a Milano con tappa a Roma da un missione a Palermo, non stancante ma con le parti di camminamento soprattutto aeroportuale defatiganti. Alla sera scoppia un febbrone a 39,6. Con i tempi che corrono, naturali preoccupazioni (in leggero stato confusionale). La parola “febbre” non crea buone relazioni. Chi consulto propende – tachipirina a parte – un controllo in Pronto Soccorso. Metto mano alla tachipirina e penso che al mattino sarò più lucido. Ma liberando alla vista le gambe, il gonfiore, soprattutto della gamba destra è stratosferico. Anche la sinistra è mal messa, ma quella destra è segnata da annerimenti e rossori, che non posso scambiare per segnali antropici della mia vecchia passione milanista. Mi viene in mente la parola “flebite” e la rete mi incoraggia nell’autodiagnosi. Troppo tardi. Ora stesi, vediamo domattina.
La tachipirina riduce velocemente la temperatura, ma il gonfiore doloroso alla pressione è immutato. Non avverto sintomi di Covid e considero quello allora il problema numero uno. Quattro telefonate a medici e strutture per una valutazione. Due paroline unificano ogni risposta: Pronto Soccorso. Tento ancora laboratori in cliniche vicine almeno per un ecodoppler chiarificatore e dichiaro per correttezza la febbre (ora calata) della sera prima. Le due paroline ritornano impietosamente: Pronto Soccorso.
E così finisco in P.S. nella scelta di un ospedale pubblico romano che mi sembra meno flogizzato (che non cito per non fare “casi”) in cui la breve dichiarazione all’infermiera palombarizzata che accoglie all’ingresso è fedele segnalando la personale preoccupazione sanitaria per la presunta flebite (che, dico al condizionale, potrebbe evolvere anche verso complicazioni polmonari) aggiungendo che non avverto alcun sintomo di Covid.
Accolto e stivato in un container di ferro, sterile, semplice, sigillato, costruito nella corte dell’ospedale per questo genere di accudimento con sospetto. Comincia qui una storia di test che – causa la ripresa delle ospedalizzazioni – non si risolvono nell’oretta complessiva del tempo netto complessivo delle operazioni, ma in tredici ore. I test sono radi, ma accurati. Anticipati dalla visita di tre minuti dell’unico medico della giornata (una giovane dottoressa attenta) che percepisce anche al tocco lo stato della gamba, ma mostra già il suo interesse prioritario per il “Covid sospetto”.

Ma ciascun test ha alcune ore di elaborazione. In particolare il tampone che arriva a metà giornata e che preannuncia esiti in cinque o sei ore. Di mezzo la Tac ai polmoni avviene con un percorso di guerra dal container all’interno per evitare ogni intrusione nei reparti. Medici non ne vedrò più per tutta la giornata. Tento la comunicazione “ma la mia gamba?”, che tuttavia non ha orecchi, salvo quelli di un portantino peruviano che fa segni di vaga comprensione e, in un caso, di un’infermiera che sosta un attimo davanti alla finestrella (chiusa dall’esterno) del container a cui riesco a fare un mimo.
Il nodo relazionale è chiaro: i medici controllano da remoto ma non interagiscono. Il personale ha ordine di non parlare per non dare messaggi imprecisi. In tredici ore solo scambi di compatimenti con il paziente del container antistante, dall’aria campagnola, che lamenta solo che da ore non si vede nemmeno un bicchier d’acqua (arriverà alle 18, insieme a una pastina in brodo, pessima ma apprezzabile).
Scoccano le 22.45 quando la stessa infermiera del furtivo messaggio si avvicina alla finestrella e mi lancia il suo confortante “Negativo!” a cui replico in mio sconfortato “E la mia gamba?”.
Dopo dieci minuti il piccolo infermiere peruviano mi acchiappa senza parole e mi trasporta a piedi – ormai ho il passaporto – verso una sorta di antistanteria delle sale di prestazioni che in realtà è un corridoio assiepato di letti-brandina con pazienti mascherinizzati, quasi tutti anziani, alcuni in condizioni per nulla brillanti, che danno l’aria di essere lì da qualche anno (evidentemente no). Non c’è tempo per le maniere, l’invito è a occupare una sedia alla parete in una fila in cui il distanziamento non è più possibile.
Passa un’altra ora. Il passaggio di un’infermiera è occasione di un’ola di domande che vengono considerate tutte inopportune. Al mio nome balzo verso la speranza di un ecodoppler liberatore entro la mezzanotte. Ma, appena entrato nel “camerone” (con scene multiple, di prestazioni, di ufficio, di controllo), mi arriva il “mèttete laggiù che te famo ‘na puntura nella pancia”). Ma come, cosa, poi, insomma…Il mio disagio deve essere interpretato come l’evidenza di un soggetto rompicoglioni e siccome la prestazione non è pronta vengo riportato nei corridoi. Ho il tempo di interrogarmi e di capire che non ci sarà nessun ecodoppler, che sta arrivando un’eparina per evitare coaguli e che il resto è oscuro. Così è al nuovo richiamo (per la seconda volta invitato a chiarire quale è il nome e quale è il cognome). Perfetta e rapida esecuzione. Poi capisco la volontà di trattenermi per la notte e alzo la mano per esprimere il diritto a congedarmi.
Lì per la prima volta si alza il camice bianco di una dottoressa (impegnata in un diverbio a voci sovrastanti con un’infermiera) che replica: “Sia chiaro che lei lo fa contro il parere dei medici”. Obbietto che il “parere dei medici non ho avuto la fortuna di incrociarlo, che sono grato per le prestazioni chiarificanti ma che ora posso regolare il resto togliendo il mio carico dalla pressione sull’ospedale”. La reazione innervosisce la dottoressa che mi spiega che i medici seguono e sanno tutto. Ho il tempo di dire che il paziente ha il diritto di accorgersene e di avere anche scarne informazioni dirette alla sua portata di comprensione. Vale per tutti, toglie disagio e mette in condizioni di un minimo di auto-organizzazione. Mi mostra la pila dei fascicoli dei ricoveri come per dirmi: si accontenti di quel che è possibile. Sì, mi accontento di quel che ho avuto. Ma uso l’ultima energia per dire: “Ho l’impressione che sia ripartita l’onda del Covid come priorità politica”. La reazione è più stizzita: “Come si permette?”. “Non dico politico per dire di parte – provo – ma come totalizzazione delle priorità così da far rischiare alla fine di derubricare altre patologie, magari la mia non è da codice rosso, ma temo che si perda il controllo”. Non ci pigliamo. E dieci minuti dopo sono su un taxi.
Il giorno dopo – con il passaporto della “negatività” e senza febbre – constato da una angiologa che non è flebite, ma comunque un trasferimento di liquidi dal sistema venoso ai tessuti, con processi di alterazione che vanno affrontati subito. Ora – dopo anche visita dermatologica – ho una batteria di compresse, gel e punturine per un mesetto di trattamento. Sono pienamente operativo.
Dico a me (e qui a voi) che l’onda violenta di Covid mette le nostre strutture in condizione di replicare – sì, di replicare – ma con una certa unilateralità, che l’infrastruttura che vedo è bisognosa di enormi modernizzazioni (Mes subito e piani di adeguamento) e infine che la comunicazione sanitaria è – in questo genere di tipologie – all’ora zero.
PS (qui inteso come post-scriptum) – Se c’è un contenuto giornalistico che si adatta appieno al titolo di questa mia rubrica (“La finestra sul cortile”) è proprio quello di questo articolo.