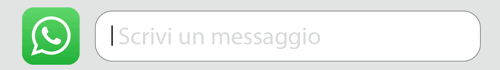Esiste un arco temporale che sembra capace di determinare, nelle società umane, il condensarsi di cambiamenti che caratterizzeranno, da quel momento in poi, il susseguirsi degli eventi. Trent’anni, infatti, sono un periodo nel quale gli insegnamenti, le cesure storiche, i cambiamenti politici, le novità tecnologiche, le rotture sociali e culturali, a disposizione di una generazione che si affaccia da adulta alla vita, divengono mature, forniscono i primi frutti maturi, e hanno avuto il tempo di selezionare gli elementi “utili” e scartato quelli inutilizzabili, almeno in quella fase storica.
Prendiamo, ad esempio, la elaborazione marxiana della triade “salario, prezzo e profitto” della metà degli anni ’60 dell’Ottocento. Quella “fotografia”, acuta e innovativa, sembrava svelare, e lo faceva realmente in quel momento, la relazione che si determinava tra quei fattori del processo economico di quel primo capitalismo rampante. Forniva una sintesi lampante e utile alla costruzione di una coscienza, individuale e collettiva, del proprio ruolo e della propria collocazione all’interno del processo produttivo, ad una classe che da subalterna avrebbe osato non rivendicare semplicemente una più equa redistribuzione della ricchezza prodotta, ma un diverso assetto dei poteri. Contribuiva a svelarne i meccanismi di accumulazione, di sfruttamento e indicava i terreni di rivendicazione che avrebbero innervato le lotte del ‘900.
Trent’anni dopo, negli USA, affioravano i primi studi sulle possibili modifiche dei comportamenti nel mercato. Matthew Brown Hammond, con il suo lavoro sull’industria del cotone del 1897, inaugurava un approccio diverso al mercato che proprio in un trentennio avrebbe generato il suo frutto “maturo”, quello della messa a punto di un funzionamento sistemico, il marketing, che chiamo “arma di costruzione di massa”. Ci vollero trent’anni, infatti, perché quelle conoscenze assumessero una dimensione generale, innervando il “modello di produzione” della loro potenza. È proprio nei meccanismi di riorganizzazione della accoppiata “produzione-consumo-analisi del mercato-nuova produzione” che nasce quella nuova struttura circolare della stessa società che ho chiamato L’Industria di Senso e inizia a configurarsi quello che noi tutti chiameremo, in breve sintesi, il secolo breve.
Passa un nuovo trentennio e, in pieno boom economico, emerge la consapevolezza che quelle novità hanno generato già una nuova fase e di cui si inizia a rendersi coscienti a poco a poco. Il valore degli impianti di una azienda e il suo stesso volume di affari, non può più essere calcolato come in precedenza – capitale fisso, fatturato, indebitamento, ecc… – ma deve essere moltiplicato per un moltiplicatore variabile, diverso da settore industriale a settore industriale, in funzione di un dato puramente “immateriale”, addirittura “simbolico”: il “valore percepito” di un marchio. Inizia ad emergere, in maniera esplicita e riconoscibile, un nuovo fattore dell’equazione economica che era stato misconosciuto perché la sua dimensione, fino ad allora, poteva essere considerata trascurabile nei calcoli. Il valore di un marchio, nella nuova società capitalistica dominata dall’Industria di senso, poteva raddoppiare, triplicare, quintuplicare il valore “materiale” di una azienda, così come già faceva per quello dei suoi prodotti presenti sul mercato. Il valore dell’”immateriale” iniziava a condensare la sua presenza nella produzione e nel soddisfacimento del bisogno ben prima della diffusione di massa dell’informatica, una tecnologia che, però, proprio per questo diveniva sempre più importante e necessaria per il nuovo ciclo economico.
Doveva passare un altro trentennio per arrivare alla prima consapevole presa d’atto che il valore dell’informazione, quell’elemento “immateriale” in genere misconosciuto dagli economisti e dai politici, era un elemento ben più concreto di quanto i “classici” erano in grado di comprendere con gli schemi fermi e rigidi dell’Ottocento. Qualcuno cominciava a comprendere che la “complessità” dei fattori in gioco era molto più alta di quella fino ad allora utilizzata e che le stesse “leggi” di funzionamento dei processi economico-sociali non poteva essere affrontata con gli schemi “meccanici classici”. Questo non significava che le ragioni delle diseguaglianze o dello sfruttamento fossero “superate”, anzi, ma solo che la potenza “sistemica” delle strutture era divenuta “qualitativamente” diversa e più alta, e che erano necessarie nuove analisi e nuove capacità di comprensione in grado di fornirci un nuovo “anticipo”, come ci era stato consegnato nell’Ottocento dal pensiero marxiano.
È proprio in concomitanza con la caduta del muro e la fine del “socialismo reale” (definizione che, per i detrattori serviva a distinguere le intenzioni – buone – dalla pratica – nefasta – e, per i fautori, la possibilità “concreta” di un altro modello di organizzazione dell’umano rispetto “allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo”) che Paul Romer, che sarebbe diventato premio Nobel per l’economia del 2018, pubblicava i suoi studi sul valore dell’informazione nel ciclo economico. Erano proposte perlopiù ignorate al momento sia dagli apparati produttivi sia dagli accademici “tradizionali” e dalla “politica” e che “rivoluzionavano” lo schema di lettura dei processi di produzione, evidenziando processi che già erano in atto nella concreta economia che stava per essere investita dalla potenza del “digitale”. Proposte che avrebbero impiegato trent’anni per aver riconosciuta la loro dignità teorica, un arco di tempo in cui l’economia reale, invece, le aveva inglobate nelle sue prassi, facendone il nuovo fulcro del modello.
Mentre nell’economia capitalistica la dimensione del valore dell’informazione nella produzione veniva ad emergere in tutto il suo potenziale essendo inserita nell’intero ciclo (dalla ideazione alla produzione, passando per la distribuzione e il consumo, tutto “supervisionato” dalla logica, di fatto cibernetica, del marketing), le economie socialiste erano rimaste sostanzialmente “bloccate” nella “logica” produttiva e di consumo “pre-industria di senso”. Non che nei decenni che precedettero al crollo nell’URSS non si fossero confrontati con il tema di quella che allora veniva chiamata Cibernetica, la capacità di rendere “matematizzato” il funzionamento di sistema. Certo, le scomuniche staliniane sulla meccanica quantistica, sulla relatività einsteiniana, sulla cosmologia, sulla cibernetica, culminate nella “sistematizzazione” di una vera e propria “dottrina”, detta “Zhdanovshchina”, avevano isolato e congelato le possibilità di utilizzo delle nuove conoscenze che si stavano rendendo disponibili all’umanità. Dopo le scomuniche staliniane al lavoro teorico inaugurato nel 1947 da Norbert Wiener con il suo Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Krusciov aveva riconosciuto la valenza dei processi di matematizzazione come una nuova forma di tecnica di governo e come un modo per superare la crisi economica dell’era del dopo Stalin.
L’Accademia Sovietica delle Scienze, nel 1957, aveva richiesto una accelerazione nello sviluppo e nell’uso dei computer, in particolare per la produzione delle statistiche per la pianificazione. In quel tempo, il dibattito sulla cibernetica aveva guadagnato un’aura di oggettività e nell’Unione Sovietica la cibernetica era diventata un potente paradigma scientifico. Ma il ritardo “culturale” imposto da Stalin al sistema e la scelta di confinare le novità introdotte dal valore-informazione alla mera ricerca del puro bilanciamento del ciclo “produttivo-distributivo”, senza inglobare l’elemento dinamico rappresentato dal “valore-informazione” all’intero ciclo della produzione, ponevano l’industria centralizzata e statalizzata nell’impossibilità di reggere il confronto con quella nuova “capitalistico-informativa”.
Il punto più “avanzato” e consapevole della potenza e del valore dei nuovi sistemi resi possibili dai computer e dalla forza della “logica cibernetica”, l’ingegnere Anatolii Kitov, vice-direttore del Computation Center e importante esponente del Ministero della Difesa, descrive con chiarezza il terreno di utilizzo che la società sovietica si proponeva. In un documento a Krusciov del 1959, l’ingegnere teorizza che l’informatizzazione «rende possibile utilizzare in pieno i principali vantaggi economici del sistema socialista: economia pianificata e controllo centralizzato. La creazione di un sistema di gestione automatizzato […] assicurerebbe una vittoria completa del socialismo sul capitalismo». Il tema del confronto tra i sistemi, però, non era più di tipo “quantitativo”, come era sembrato e continuò ad essere percepito per alcuni decenni, ma ormai di natura “qualitativa”.
Nell’URSS, ancora strutturalmente staliniana, si pensava di poter utilizzare le regole cibernetiche per ottimizzare le logiche burocratico-amministrative, mentre la potenza della “logica nuova”, generata dai processi di feedback permanente dei comportamenti dei singoli, e che l’Industria di Senso aveva inaugurato a cavallo della Seconda guerra mondiale, stavano generando già un capitalismo di nuovo tipo, un capitalismo che basava la sua nuova capacità produttiva nella spirale permanente di “costruzione del senso della vita-modello di consumo-consenso politico” che si proponeva di ingoiare l’intero pianeta e che necessitava, per questo, di un permanente aumento della capacità di calcolo e di accumulo di dati. Uno slittamento del confronto, uno smarcamento totale del terreno della competizione, un cambio in corsa del gioco e delle sue regole, a cui né i paesi allora “socialisti”, né le forze politiche della sinistra nella “sfera capitalistica” riuscirono a comprendere e a contrastare.
Il crollo del muro, simbolicamente, rappresentò la “consapevole” conseguenza di tale incapacità strategica di comprendere le nuove qualità del capitalismo, qualità che andavano ben oltre quelle ipotizzate un secolo prima da Marx e sessant’anni prima da Lenin, oltre la fabbrica artigiana prima e fordista poi, oltre la finanziarizzazione, intendendo per “oltre” un processo di sussunzione all’interno di un nuovo schema e non la loro scomparsa.

Ora sono passati altri 30 anni. Quelle che allora, possiamo dire, erano delle semplici annunciazioni di “metodo” – applicate ai processi produttivi più avanzati e sui quali il movimento dei lavoratori non ha voluto dispiegare la sua “critica del conflitto” per incapacità di lettura dei processi da parte dei suoi gruppi dirigenti – iniziano a dispiegare la loro potenza attraverso le nuove applicazioni dei processi di digitalizzazione dell’intelligenza artificiale e della robotica. I primi vagiti di una nuova fase che sta consolidando nuove forme di produzione di valore che vanno ben oltre gli schemi dell’era industriale e delle figure sociali a loro connesse. Processi così profondi da recidere i legami tra le organizzazioni politiche e sociali che il mondo del lavoro aveva costruito nel secolo e mezzo nell’era industriale e i soggetti sociali di riferimento. Saltano le rappresentanze e le dislocazioni sociali, investite dalla forza dei processi in atto. Si sciolgono le capacità delle forme istituzionali nazionali ad affrontare il nuovo quadro.
Quella a cui stiamo assistendo, infatti, non è una “crisi”, ma l’inizio di una fase di passaggio, una Transizione da un modello di produzione del valore ad un altro. Questo passaggio rappresenta una rottura profonda degli schemi di valorizzazione del capitale, la crisi delle forme istituzionali di stampo liberale, quelle nate dalla vittoria della borghesia industriale contro le istituzioni dell’Ancien Régime e le sue evoluzioni novecentesche. Gli stessi tentativi di costruzione di entità di regolazione sovranazionale, nate sotto la pressione dei processi di globalizzazione e della impossibilità degli stati nazionali di essere strumenti efficaci – sia del governo dei processi economico-produttivo, sia di garantire processi partecipativi e decisionali di matrice democratica – sembrano una fase di passaggio verso la necessità di nuove forme istituzionali che la nuova produzione di valore esige. Rotture che spingono a reazioni uguali e contrarie che alimentano i sovranismi e i neonazionalismi attraverso la diffusione di un inganno: che sia possibile affrontare la Transizione con il ritorno alle autonomie territoriali uscite dalla rottura ottocentesca dei vecchi regni.
Dalle guerre apertamente guerreggiate come quelle in Siria, si affiancano, per citare le più evidenti, le crisi in Birmania, nel Burkina Faso, nell’area tra Iran, Arabia Saudita e lo Yemen, tra Pakistan e India, l’occupazione del Kashmir e i rapporti con la Cina, la guerra in Centroafrica e nel Sud del Sudan, l’Ucraina, il Venezuela, la Libia, l’Egitto, Israele e i palestinesi, e poi le crisi “sociali” come quelle del Cile, dell’Amazzonia, dalle rivendicazioni nazionalistiche della Brexit e del Québec, o dei Curdi o degli abitanti di Hong Kong o da quelli della Catalogna, dai gilet gialli francesi alle mobilitazioni algerine, libanesi passando per quelle irachene e russe; dalle crisi politiche di nazioni, che non riescono a trovare un “equilibrio” governativo come la Spagna o l’Italia, alla crisi di istituzioni sovranazionali come l’ Unione Europea, che non riesce a varare il proprio governo o la crisi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio che non riesce più a governare i rapporti di scambio tra aree produttive nel mondo, l’intero quadro planetario sembra scricchiolare visibilmente proprio mentre la consapevolezza che le soluzioni non possano che essere planetarie mettono radici profonde attraverso il contagio della consapevolezza del passaggio epocale che la storia umana sta attraversando: quello dell’obbligo di rendere compatibile il fare umano con le necessità di mantenimento dei cicli di vita e ambientali del pianeta.
La Transizione, però, fa emergere, lungo le faglie che produce negli assetti del potere esistente costituito, nuove forme di valorizzazione e di soddisfacimento dei bisogni che si possono definire post-capitalistiche. Certo, passano per forme di conflitto diverse da quelle che, erroneamente, per alcuni decenni abbiamo definito “classiche”. Le novità introdotte dal nuovo capitalismo, ad esempio, mutano anche le forme del “lavoro” e fanno emergere nuove categorie di conflitto che non sono inquadrabili dentro lo schema del conflitto “capitale-lavoro salariato”. Il compito dell’oggi, per la sinistra di questo secolo, è quello di contribuire alla “normalizzazione” di queste nuove forme e “ricondurle” nello schema capitalistico del lavoro salariato o di spingere verso esiti più avanzati le nuove modalità producendo nuovi assetti sociali e di potere?
La caduta del muro trent’anni fa sembrò travolgere le dinamiche storiche costruendo “società mutanti”, società, cioè, nelle quali tutto cambiava in maniera cangiante e incessante, lasciando inalterato il sistema del potere e le sue classi dominanti. La trasformazione dei processi di produzione, introdotta dalla potenza del valore-informazione che il digitale ha reso invasivo in ogni aspetto della economia e della vita, travolse la capacità dei “paesi socialisti” di reggere il confronto con le società occidentali, ma sta ora investendo gli assetti di quelle stesse società che generarono tale processo. Solo che stavolta la mancanza di una teoria critica adeguata e di organizzazioni politiche e sociali in grado di orientare le forme del conflitto nel nuovo scenario, rischiano di impedire non la capacità di affrontare una “crisi economica”, ma una vera e propria crisi di civiltà e del suo crollo.
Il problema politico che attraversa la società contemporanea è racchiuso tutto nel tentativo di comprendere i processi in atto attraverso gli occhiali della realtà precedente. Ci si immagina il processo in divenire con gli schemi validi nella vita di ieri. Alcuni lavorano fortemente al tentativo del ripristino degli equilibri precedenti, anche se, in quella realtà, li vedevano come dei subalterni. L’insegnamento dell’Ottobre, a mio avviso, fu quello di cogliere la fase di Transizione della società russa, dalla struttura contadina a quella industriale, e saper offrire alle due classi subalterne (contadini e operai, la falce e il martello) un terreno unitario di interessi. Ma ciò fu possibile solo perché la teoria sottostante affidava all’orizzonte dischiuso dalle lotte della nuova classe emergente, quella operaia, la costruzione di un immaginario legato ad un grado di libertà più alto di quello della vita contadina. Erano quelle aspirazioni a guidare il “senso”, non una idea di lavoro tout court.
Oggi, purtroppo, si pensa di “ripristinare” un “orizzonte di senso” per la sinistra, senza aver compreso le dinamiche del nuovo lavoro che questo capitalismo ha dischiuso, senza una teoria della liberazione da questa condizione di nuovo sfruttamento e senza saper indicare una geografia delle classi e dei poteri. Ci si illude di poter utilizzare il “basso” contro “l’alto”, di sposare le mere rivendicazioni “quantitative” di “un po’ più di ricchezza per tutti”, di trovare la soluzione nelle fiammate delle rivolte, cose che, nel terzo millennio, avremmo dovuto aver compreso che servono più a scaricare tensioni, individuali e sociali, e, alla fine, a contribuire a stabilizzare lo status quo. Oppure si pensa che sia sufficiente qualche elemento redistributivo in più (più tasse per più servizi) e dimostrarsi più capaci di far funzionare “questo” sistema. Dentro questa tenaglia di impostazioni “impotenti” le sinistre stanno morendo in tutto il mondo.
La Transizione, quindi, necessita di una nuova teoria, di indicare nuovi orizzonti, nuovi gradi di libertà, di far emergere le persone che sappiano socializzare, raccontare, narrare questi nuovi “bisogni politici” e dare forma organizzata alle azioni necessarie per renderli concreti. Quello sarà il nuovo gruppo dirigente e quella la nuova formazione organizzata della politica della sinistra di questo secolo.
Sempre che il vecchio non abbia già ucciso nella culla il nuovo che stava nascendo. Per il prossimo trentennio.