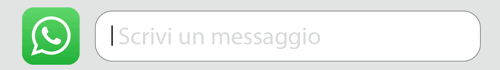“Cerbero, fiera crudele e diversa,
Con tre gole caninamente latra
Sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ‘l ventre largo, e unghiate le mani;
graffia li spirti, ed iscoia ed isquatra,
Urlar li fa la pioggia come cani;
de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo;
Volgonsi spesso i miseri profani.
Quando si scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
non avea membro che tenesse fermo.
E ‘ l duca mio distese le sue spanne,
prese la terra, e con piene le pugna
la gittò dentro a le bramose canne.
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,
e si racqueta poi che ‘l pasto morde,
chè solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, che ‘ ntrona
l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde. (Dante , Inferno, canto VI vv 13-33)
Siamo poco dopo l’incipit del VI canto dell’Inferno tra gli INCONTINENTI, esattamente nel III cerchio destinato ai golosi dove Dante incontra Cerbero.
Cerbero è un essere mitologico con tre teste canine, figlio di 2 creature mostruose, Tifone ed Echidna, e fratello di esseri orribili come l’Idra di Lerna e Chimera.
Ha un corpo gigantesco ed è sempre pronto a latrare furiosamente.
La sua ingordigia irrefrenabile è stigmatizzata da un ventre largo, da una bocca sudicia, dalle zanne e dalle zampe artigliate.
Nell’età del Medioevo era anche il simbolo dell’odio di parte, non a caso Dante lo colloca nel VI canto, un canto politico, in cui affronterà con Ciacco la drammatica realtà delle discordie fiorentine.
Cerbero, il “gran vermo”, colpisce per il suo essere spregevole e ripugnante ma soprattutto per il suo LATRARE caninamente, tanto che “l’anime vorrebber esser sorde”, e per i suoi gesti ripugnanti: la continua agitazione delle sue membra costituisce, difatti, il tratto dominante della sua terrificante raffigurazione. È la materializzazione di una parola e di una gestualità scomposta e violenta che abbrutisce e degrada allo stato ferino.
Il nostro tempo, ahimè, è un tempo “cianotico”, pieno di grida e parole, offensive e minacciose, nelle grandi realtà come nelle piccole, sul Web, nelle piazze, nei luoghi pubblici. È pieno di livore, di bocche sgangherate da far gonfiare le vene del collo, da competere addirittura col latrare di Cerbero. Anche il mio piccolo paesino cilentano, in occasione delle recenti amministrative, non si è sottratto dal mettere in scena l’indegno spettacolo di urlatori alla carica soltanto per offendere, denigrare, aggredire e “dividere” a scapito di ogni riflessione politica e programmatica.
Si parla, o meglio, si proclama ma per ululare, abbaiare, grugnire, dare morsi, producendo piccoli pezzi di “pregiata” oratoria in cui semantica, lessico e sintesi sono sempre di un’estrema povertà interiore. È un parlare tossico, ricco di “verità alternative”, condite di velenosi liquori all’essenza di umori divisori e funzionale all’autoaffermazione selvaggia del proprio ego ipertrofico.
È un parlare che registra l’annullamento di ogni filtro critico, incapace di fondare un pensiero “dignitoso” condivisibile, della serie dico ciò che l’impulso mi detta e lo faccio anche pubblicamente senza ritegno e senza vergogna perchè “questa è per me l’unica realtà esistente”. È la regressione ad una illusoria condizione di onnipotenza che nasconde una inconscia consapevolezza di impotenza.
È cosi che il linguaggio perde la sua dignità, cioè il suo dover essere rispettabile, controllabile e sottoponibile a verifiche etiche per divenire pubblico. In questo contesto tutto può essere dicibile e niente è vero. E l’ho sperimentato sulla mia stessa pelle e a mie spese: un confronto che è stata una catabasi, una discesa agli Inferi, ci si salva solo se, come Orfeo, ti volti a guardare in faccia “la morte” per poi ritrovare la luce.
Platone nei Dialoghi affermava che la parola deve essere il risultato di uno scavo interiore capace di generare una riflessione sul bene e sul giusto. Heidegger che il linguaggio è la casa del proprio essere, se i due filosofi hanno detto bene questa casa molto spesso è la sede di una sub cultura dove si scatena una rabbia senza freni che travalica ogni misura e pericolosamente ogni norma di civile convivenza e democratico confronto.
Quando poi il volume degli istinti incontrollati oltrepassa di gran lunga il numero di parole a disposizione, esiguo, si ricorre alla gestualità di una “leggerezza bovina” di cui si ci compiace tanto da metterla in scena ostentandola platealmente sotto lo sguardo compiaciuto di “raffinati” accoliti.