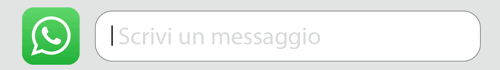Una settimana addietro (domenica 13 ottobre), a Cosenza, le organizzazioni “sudiste”, attive in diverse realtà meridionali, si sono riunite per denunciare gli effetti negativi che l’unità d’Italia (dall’anno 1861 in qua) ha avuto per il Sud. Il Corriere della Sera ha presentato l’evento su un’intera pagina con un titolo ad effetto “I neoborbonici – tra sovrani e sovranisti”.
La questione meridionale appassiona gli studiosi da oltre un secolo, e i governi che nel frattempo si sono succeduti hanno cercato di venirne a capo. Ma, il divario tra Nord e Sud dell’Italia continua a rappresentare uno dei problemi di fondo sul piano economico e sociale. Basti pensare al corollario costituito dalla secolare emigrazione e, negli ultimi decenni, dalla “fuga di cervelli” che assomma alla povertà materiale la perdita di valore umano e quindi di una risorsa primaria anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno.
Uno sguardo ai dati, seppure molto limitato, offre la drammatica conferma di una realtà negativa. Nel 1971 il reddito pro-capite del Meridione era pari al 74% di quello del Centro-Nord, nel 2018 il rapporto è sceso al 54%.
I neoborbonici hanno dunque ragione? Di sicuro non hanno tutti i torti, sebbene vada detto che anche i meridionali hanno una parte non indifferente di responsabilità.
Andando con ordine, a partire dal secondo dopoguerra, la “curva delle opportunità” a vantaggio del Sud segue un andamento altalenante, che diviene più negativo con il passaggio dal ruolo e dalle competenze centrali a quelle delle amministrazioni regionali.
La nascita della Cassa per il Mezzogiorno
Nel 1950, con il governo De Gasperi, su impulso di un gruppo di menti illuminate di diversa estrazione culturale e politica (tra essi Pasquale Saraceno,economista cattolico; Donato Menichella, laico liberale governatore della Banca d’Italia; Rodolfo Morandi, economista e politico socialista) venne varata la legge n. 646 che costituiva la Cassa per le opere straordinarie di interesse pubblico nell’Italia meridionale, la cosiddetta Cassa per il Mezzogiorno.
Il modello al quale la Cassa si ispirava era quello della Tennessee Authority Valley, ideato dal presidente americano Frank Delano Rooswelt per uscire dalla depressione seguita alla grande crisi del 1929. Programmi, finanziamenti, esecuzione di opere straordinarie. Furono individuate aree di sviluppo industriale (ASI) con consorzi promossi da comuni, province e camere di commercio (le regioni a statuto ordinario ancora non erano costituite).
La legge 646 destinava la Sud 100 mila miliardi di lire (circa 50 miliardi di euro) per dieci anni. Alle regioni meridionali andò un totale di 82.410 miliardi di lire, con una spesa media all’anno di circa lo 0,65% del Pil.
I risultati: 16.000 chilometri di collegamenti stradali; 23.000 km di acquedotti; 40.000 km di reti elettriche; 1.600 scuole; 160 ospedali; opere di irrigazione delle campagne. Gli appalti furono giganteschi, anche se molte opere restarono incompiute e si dovette lamentare che alcune di quelle realizzate rimasero come “cattedrali nel deserto” poiché al loro intorno non si sviluppò una rete consistente di attività indotte. L’intervento della Cassa, nel primo quindicennio di attività, consentì di realizzare il massimo di convergenza del Sud con il resto del paese. Quelle strutture costituiscono a tutt’oggi buona parte della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno.
Le risorse da sole non bastano. Allora, operarono insieme una classe dirigente, competenze tecniche e capacità di controllo sulla spesa, fu un esempio di quello che dovrebbe essere un’agenzia pubblica. Con il 1971 e l’avvento delle regioni iniziò il diluvio.
Incentivi Europei
Dopo la Cassa del Mezzogiorno arrivarono gli incentivi in chiave europea (legge 19.12.1992 n.488), e vennero definite delle priorità sulla base di piani attuativi annuali, mentre le competenze e la gestione delle risorse furono affidate affidate a tecnostrutture. Con la legge obiettivo n. 443 del 2001, le competenze passarono al CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) al quale venne demandato il compito di riequilibrare lo sviluppo socio-economico delle varie aree del territorio nazionale,con incentivi destinati per il 52,2% al Centro-Nord e il 47,8% al Mezzogiorno.
Delle opere programmate nel decennio che va dal 2001 al 2011, ne è stato ultimato solo l’11% a livello nazionale, con al Sud soltanto il 6%.
I neoborbonici dovrebbero così guardare anche all’interno delle realtà politiche che li circonda, sebbene non abbiano tutti i torti. In effetti, l’Italia sta investendo al Sud troppo poco, tanto che la Commissione Europea minaccia di tagliare i fondi strutturali. La lettera di Bruxelles è arrivata all’inizio del mese. Rispetto al contributo che versa al bilancio europeo (15,7 miliardi di euro nel 2018), l’Italia riceve complessivamente 8,85 miliardi di fondi per incentivare le proprie strutture economico-sociali.
Secondo i dati della Ragioneria dello Stato, i fondi europei del 2018 sono pervenuti all’Italia tramite il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) per 4,074 miliardi i euro, il Fers (Fondo europeo di sviluppo regionale) per 1,755 miliardi, Fse (Fondo sociale europeo) per 1,23 miliardi. Per lo sviluppo regionale (Fers) la Puglia ha ricevuto 203 milioni di euro, la Sicilia 190, la Campania 123, la Calabria 108. Dal Fondo sociale (Fse), avente l’obiettivo di “realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale, migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro”, la metà è andata alle amministrazioni centrali, l’altra direttamente alle regioni Lombardia (135 milioni di euro), Piemonte (100 milioni), Sicilia (74 milioni), Campania (60 milioni), a scendere tutte le altre.
La gestione dei fondi da parte delle Regioni
Il volume di fondi al Sud è stato consistente, non sufficiente a risolvere definitivamente la “questione meridionale”, ma abbastanza per avviare un rinascita. Quanti di quei fondi siano stati spesi, per quali obiettivi e come, e con quali risultati, lascia perplessi. I destinatari istituzionali, in primo luogo le Regioni, cosa hanno prodotto? La domanda non è casuale e merita una risposta che non c’è, se è vero che la Commissione Europea, come si ricordava prima, è in allarme e minaccia di chiudere i rubinetti.
Spesso, in passato, si è detto che il sistema del credito – flussi di risparmio e investimenti – ha penalizzato il Mezzogiorno nel senso che le banche hanno pompato molto dal risparmio e poco finanziato le attività meridionali. La storia è antica e, purtroppo, autentica. La situazione è resa più ostica dal fatto che a seguito della riorganizzazione del sistema bancario nazionale, sono scomparsi storici istituti di credito meridionali come Banco di Napoli e Banco di Sicilia, che certo non avevano brillato per la loro gestione. Tant’è che si è tornati a parlare dell’istituzione di una “Banca per il Mezzogiorno”, un progetto più velleitario che reale stante l’astrattezza del capitale destinato a supportarne un’attività continuativa e penetrante verso il tessuto economico locale. Servirebbe l’impegno del sistema bancario nel suo insieme, ma esso è legato alle prospettiva di redditività dell’esercizio del credito che, nella situazione data, restano un’incognita.
Qualche segnale non manca. Intesa Sanpaolo, la maggiore banca italiana, ha reso noto che, a marzo 2019, nel Sud, a fronte di una raccolta di circa 42 miliardi ha investito circa 51 miliardi. Una buna notizia, che si accompagna al patto “per il Sud” sottoscritto, in questo mese, tra Confindustria e le maggiori organizzazioni sindacali, Cgil,Cisl e Uil.
Cosa fare per favorire una ripresa economica?
Che sia un buon inizio favorito dalla prospettiva di maggiore stabilità politica legata al nuovo governo e al suo obiettivo di lavorare per la ripresa economica? In questo ambito si annunciano interventi a sosteno dell’imprenditoria e del lavoro, compreso il taglio del cosiddetto cuneo fiscale. Con quali risorse?
Per prima cosa dando un taglio alla spesa pubblica nella parte dove rappresenta uno spreco, per non dire uno scandalo. Con un minimo di impegno, che in contraddizione comporta un grosso sforzo politico clientelare, i settori dove sforbiciare non mancano. Persino nel governo attuale c’è chi si pone il problema, ad esempio eliminando quella “quota 100”, a vantaggio di soggetti che hanno lavoro e reddito dragando risorse per miliardi di euro ogni anno.
Per facilitare l’attività imprenditoriale con agevolazioni e incentivi, nel 2017 (D.L. 91/2017) sono state istituite le cosiddette Zone ZES, potenziando il bonus istituito dalla legge di stabilità precedente (L.208/2015), che riguarda aree portuali e aree non adiacenti ma con nesso economico funzionale, interporti e piattaforme logistiche. Finora, sono state costituite tre Zes, in Campania, Calabria e area jonica (Puglia e Basilicata).
Le imprese, nuove o già esistenti, operanti nell’ambito di una Zes, che avviano un programma di attività economico imprenditoriale o di investimento di natura incrementale nella stessa area, usufruiscono di agevolazioni sotto forma di credito di imposta, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Le agevolazioni sono riconosciute ad attività che durano almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento e possono coprire solo altri 7 anni. I fondi disponibili sono però complessivamente limitati: 50 milioni di euro nel 2019, 150 nel 2020 e 100 nel 2021. Poca acqua rispetto ad un vasto deserto. Se le risorse disponibili sono scarse, l’idea che sta alla base delle Zes non è malvagia ed anzi potrebbe essere allargata gratuitamente. Come?

Un nuovo ruolo per le Regioni del Sud
Partendo da quell’esempio, si può immaginare di istituire aree di sviluppo economico industriale e tecnologico a costo zero. Chi investe con attività innovative in zone siffatte, predeterminate d’intesa tra Stato Comuni e Regioni, è esente da imposte, locali e statali, per un determinato periodo di tempo (per esempio da 10 a 15 anni) sufficiente a far decollare l’impresa. Con l’aggiunta che anche quelle attività possano usufruire degli incentivi previsti dai fondi europei Fers e Fes. Agli enti locali interessati (comuni e soprattutto regioni ), quale contropartita dell’incremento socio economico che ne deriva, va attribuito il costo per dotare le aree prescelte delle infrastrutture necessarie. Il presupposto riguarda la semplificazione delle pratiche amministrative, abbattendo i costi e riducendo i tempi.
In sostanza, si tratterebbe di replicare su vasta scala, a livello locale, l’idea di “agenzia” come fu per la Cassa del Mezzogiorno che, a sua volta, la mutuò dal “new deal” americano.
Le autonomie locali verrebbero rafforzate e, non di meno, messe alla prova. Le regioni e gli enti locali che dimostreranno nei fatti di lavorare per lo sviluppo sarebbero avvantaggiati. Quelli che continueranno con politiche di basso profilo, privilegiando interessi politico clientelari, resteranno al palo.
Una politica di responsabilità per far cadere in maniera considerevole la lamentela del Sud abbandonato. I neoborbonici sarebbero costretti a riconoscere che l’Italia unita non li dimentica. Se poi, taluno, allo stadio S.Paolo di Napoli, amerà sventolare il vessillo gigliato del Regno delle due Sicilie, lo farà ricordando un antico comando: “facite ‘a mmuina!”