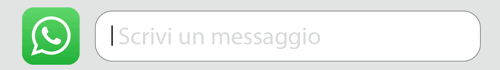Il 18 Agosto è morto Cesare Romiti. Il suo nome è legato indissolubilmente alla Fiat, essendo stato uomo di assoluta fiducia e talvolta alter ego di Gianni Agnelli – come scrive Francesco Manacorda su Repubblica – sebbene sempre in un rapporto segnato dalla consapevolezza comune di una profonda distinzione di ruoli.
Agnelli regna, Romiti comanda – si diceva a Torino e in tutta Italia. Giornali e tg ne hanno celebrato le gesta, santificandolo. Certo, di un morto non si parla mai male. Ma di un personaggio che, nel bene e nel male, ha “fatto” la storia italiana tra gli anni 70 e i 90, è lecito guardarne luci ed ombre. E farsi delle domande.
Proprio perché ha “governato” l’azienda automobilistica più importante d’Italia (e per tanti anni l’unica) la sua storia non è solo sua.
Arriva in Fiat nel 1974 come direttore finanziario. Ma non veniva dal nulla. Prima c’è il gruppo Bomprini Parodi Delfino, dove gioca un ruolo chiave nella fusione con la Snia Viscosa, di cui assume poi la guida. E in questa occasione conosce Enrico Cuccia, per anni e anni dominus incontrastato dell’industria e della finanza, una conoscenza che piano piano si trasforma in una amicizia che durerà tutta la vita. Anzi, sarà Cuccia a vegliare sempre sulla sua carriera e sarà Romiti il braccio armato di Cuccia nelle operazioni più importanti di Torino.
Nel ’70 è amministratore delegato dell’Alitalia, un’esperienza che lui stesso definirà come “la più brutta della mia vita”. Nel ’73 è all’Italstat. Tutti mi identificano con la Fiat – ebbe a dire in una intervista – ma avevo 51 anni e non è che fino a quel momento ero stato con le mani in mano. Una rivendicazione della sua identità, perché Cesarone (era un uomo alto e imponente) ha un carattere ben deciso, forte e non ama farsi contraddire. “Io sono molto molto molto più cattivo di Gianni Agnelli” – dirà a Gianni Minoli in una intervista a Mixer.
Difficile dubitarne perché in 5 anni aumenta in modo esponenziale il suo potere all’interno dell’azienda torinese. Gli italiani erano abituati (oggi le cose sono molto cambiate) a considerare la Fiat come un regno all’interno della Repubblica. Intoccabile come le Loro maestà, era tutto Fiat: compravamo le loro macchine, acquistavamo abiti e cosmetici nella Rinascente (della Fiat attraverso le sue finanziarie), mangiavamo le merendine Danone e i formaggini Galbani (idem), ci assicuravamo presso la Toro assicurazioni (idem) e tanto altro ancora.
C’è stato un momento in cui Corso Marconi (poi ha cambiato sede della dirigenza, spostandosi al Lingotto, storico stabilimento voluto dal fondatore Giovanni) dava lavoro in tutto il mondo a 350 mila persone. La Fiat era il Potere e pochi, molto pochi sapevano delle lotte feroci che si svolgevano al suo interno.
L’uscita di Valletta – che aveva governato con un polso che definire di ferro è un eufemismo – aveva scatenato una guerra del potere soprattutto tra i “vecchi” vallettiani e i due eredi Gianni e Umberto che volevano svecchiare lo staff. Veleni e coltellate nei corridoi. Tutto nel più assoluto silenzio e segreto.
Il low profile è sempre stato una caratteristica della Casa e Romiti vi si atterrà sempre. Anzi, proprio questa sarà una cosa che Cuccia (altro cultore del silenzio) apprezzerà molto. Secondo Giorgio Galli (Gli Agnelli) un’altra cosa che colpirà il dominus di Mediobanca è l’atteggiamento “monacale” che si manifesta nel rifiuto di detenere azioni: “per un vero finanziere, secondo il modello cucciano, gli interessi personali devono essere lasciati alla porta del convento”.
Gli danno una stanza al quarto piano, mentre i padroni stanno all’ottavo. Lui si fa dare i conti dell’azienda e – ripeterà più volte – rimane basito: gli Agnelli non avevano i soldi per fare le paghe e le tredicesime di fine anno. Come era potuto accadere?
Facciamo un passo indietro. Nel 1973 era scoppiato il conflitto arabo-israeliano e la questione palestinese. Il prezzo del petrolio era schizzato alle stelle, scuotendo alle fondamenta l’economia mondiale. Figuriamoci cosa vuole dire per una industria che produce auto.
Nel 1971 Umberto Agnelli è amministratore delegato unico, il primo della famiglia dopo il Fondatore Giovanni, a guidare il gruppo. Vuol far vedere che si cambia davvero e i vecchi vallettiani tremano e rabbrividiscono: il “fratello di ricambio”, “l’altro Agnelli” – così lo chiamano sdegnosamente – ha idee balorde! Si rivolge a Bruno Visentini, che ha preso il posto di Olivetti nell’azienda di Ivrea e ha una forte ammirazione per Adriano, che gli consiglia due uomini per affiancarlo, tutti e due provenienti dalla Olivetti: Nicola Tufarelli e Paolo Volponi. Quest’ultimo, di simpatie comuniste, “avrà per un certo periodo – scrive Angiolo Silvio Ori nel suo libro Storia di una dinastia. Gli Agnelli e la Fiat – la funzione di far maturare nel vertice Fiat l’esigenza di sperimentare una nuova democrazia industriale come via d’uscita alla crisi”. Torino non è Ivrea, tuonano i vecchi manager, Umberto risponde che hanno una mentalità arretrata. Ma prima Volponi e poi Tufarelli lasceranno Corso Marconi.
Invano Umberto chiederà al governo i promessi programmi pubblici nel settore ferroviario e nell’autotrasporto. I politici non gli rispondono nemmeno. Nel 1974 l’Avvocato è presidente della Confindustria, a Torino ci sta sempre meno e in fabbrica c’è l’inferno: scioperi e sabotaggi non si contano.
Umberto sperimenta la ricetta di Volponi e, dopo cento ore di sciopero, firma un accordo onerosissimo per la Fiat: 100 miliardi di lire, che si aggiungono ai 150 di passivo già previsti per l’anno in corso. E l’invenduto è salito a 350 mila vetture.
Arriva Romiti e con lui la finanza in FIAT
Dopo lunghe trattative, ottiene la cassa integrazione per 70 mila operai. Ma ormai è tardi l’indebitamento con le banche si avvia ai 10 mila miliardi di lire. Urge soluzione. E qui arriva con la veste di cavaliere bianco Cesare Romiti. Che opererà una strategia aziendale nuova: meno auto e più finanza. Una tendenza profetica: è quello che succede oggi nell’economia, dove la finanza è diventata più importante dell’industria, ma anche, allora, un errore.
Questo gli porterà molti nemici in azienda (lui li fa fuori uno a uno) e porterà la Fiat a perdere solo negli anni 80, la metà del mercato italiano (oggi non ne parliamo nemmeno). In realtà Romiti si rende conto che in quel momento “l’auto rappresentava l’unica forza e insieme la debolezza del gruppo – scrive sempre Ori – ma egli vedeva questa realtà con gli occhi e il distacco del finanziere”, non si doveva dare per scontato che tutto era perduto. Un’altra soluzione c’è sempre. Anzi, ce ne sono due.
Prima mossa: parlare con le banche. Organizza un incontro con una quindicina di istituti di credito a Milano per spiegare la situazione e chiedere una mano. Ci va con il capo della finanza di allora. “Per tutto il viaggio – racconterà Cesarone – ripeteva che vergogna, che vergogna, la Fiat che chiede i soldi alle banche”. Questo, tanto per dire come ci si considerava a Torino a quel tempo.
Seconda mossa: l’arrivo dei libici. Nel 76 Romiti conduce, insieme a Gianni Agnelli, l’ingresso della Lafico – la finanziaria del governo libico guidato dal dittatore Muammar Gheddafi – nel capitale del gruppo automobilistico, sempre con la benedizione del dominus del “salotto Buono”, Cuccia. Un boccone amaro per l’Avvocato, lui amico degli americani, di Kissinger e dei Kenndy, così inserito nella finanza occidentale da andare a braccetto con banchieri del calibro del francese André Mayer, deve mettersi in casa dei beduini. Ma la Fiat ha bisogno di soldi e la Libia ricca di petrolio ne ha. Pecunia non olet. L’operazione – nonostante il furibondo no degli Usa – riesce, i finanziamenti servono per il rilancio e quando la Lafico esce nel 1986 con il loro investimento sostanziosamente rivalutato, la soddisfazione è reciproca.
Il fulmine De Benedetti
Nel frattempo in Fiat è arrivato De Benedetti. Ci starà solo 100 giorni, ma in quei tre mesi mette a ferro e fuoco tutto lo staff manageriale, fa proposte che fanno drizzare i capelli persino ad Umberto che l’aveva portato dentro e che era stato suo compagno di scuola. Arriva come amministratore delegato e per prima cosa pretende – e ci riesce – di violare la ferrea legge vallettiana, basata sulla separazione tra azionisti e manager: si pappa il 5% delle azioni ordinarie Fiat in cambio del 60% della sua Gilardini, per un prezzo da molti considerato esoso. Diventa di fatto il secondo socio, dopo l’Ifil, la finanziaria degli Agnelli. I quali sono perplessi (anche gli altri della famiglia, non solo i due fratelli), ma urge un aumento di capitale e quindi si procede in fretta con il contratto a De Benedetti.
Romiti capisce subito che non poteva non considerare il nuovo arrivato come un uomo capace di sbarrargli la strada, anche se dichiarerà a Giampaolo Pansa: “non ero contrario, solo che mi sembrava difficile la convivenza”. E infatti lo è. Umberto – che oltre ad amministratore delegato è diventato vice presidente – per tenerlo buono, lo nomina amministratore delegato continuando a fargli seguire la finanza, insieme all’amministrazione e l’organizzazione. In pratica le chiavi della Fiat. Ma c’è un terzo amministratore delegato, De Benedetti a cui viene affidata la componentistica e la siderurgia. Poteva bastare ad un uomo come lui? No. Alberto e Giancarlo Mazzuca nel libro La Fiat da Giovanni a Luca dicono con chiarezza che “si muove come se fosse il capo”, “tratta Romiti come un dipendente”. Non solo: propone di mandare a casa un bel po’ di dirigenti, maltratta manager come Chiusano e Rossignolo (del primo, quando lo incontra, dice “sento puzza di sacrestia”, del secondo dice che le sue idee sono “aria fritta”). Si batte contro “la stupidità “ di chi vuole sostituire le auto con ospedali o cose del genere (Alberto e Giancarlo Mazzuca). Il top lo raggiunge quando propone di non distribuire per due anni i dividendi. Stavolta tutto il clan si ribella, dai Rattazzi ai Furstenberg, dai Nasi ai Brandolini d’Adda, ai Campello, ai Camerana. De Benedetti se ne deve andare. E infatti se ne va. Fu detto, al tempo, che stesse scalando in segreto la Fiat e Romiti (non dimentichiamo che ha sempre a suo fianco Mediobanca) se ne fosse accorto, svelando la faccenda alla famiglia. La solita cortina di silenzio che avvolge i fatti Fiat impediscono di dire se è vero. Certo è che due galli come loro in un solo pollaio, non potevano starci.
Via De Benedetti, Romiti accresce il suo potere in FIAT
Il peso di Romiti cresce. Anche perché Umberto si lascia tentare dalle sirene della politica e si candida con la Dc. Viene eletto con un ottimo risultato, lascia le cariche operative in Fiat ma presto si accorge che Roma non è Torino e che a Montecitorio non gli fanno toccare palla. Cesarone è solo al comando. Cerca di trasformare la azienda radicalmente mettendo alla testa dell’attività operativa una holding molto forte, taglia i rami secchi, ma soprattutto cerca soldi. E comincia a mettere in piedi una formidabile rete di potere. Gli Agnelli in queste operazioni appaiono sfuocati, incerti, senza una strategia precisa. Tom Dealessandri, responsabile Cisl in quegli anni del coordinamento sindacale, denuncia che l’azienda fa poco sul mercato medio- alto, non rinnova il parco auto (di nuovo c’è solo la Panda) mentre le altre società automobilistiche straniere hanno approfittato della crisi del petrolio per rinnovare i modelli. E’ un limite di Romiti. Pur non dichiarandolo mai (anzi, nelle interviste dice il contrario) lui considera quello che è sempre stato il core business, cioè, l’auto in secondo piano rispetto all’aspetto finanziario.
C’è anche da dire però che quelli sono stati anni tremendi alla Fiat. Non sono solo scioperi, le insubordinazioni, la violenza diffusa. Giampaolo Pansa fa un’inchiesta e si sente dire da un vecchio operaio: “Mirafiori è come Porta Portese a Roma. Si vende e si compra di tutto, tranne le locomotive ma solo perché non si riesce a farle entrare in fabbrica. C’è chi vende sigarette di contrabbando, chi cravatte, brioches, penne. C’è chi fa il barbiere a tempo pieno e c’è chi scopa: si prende i 40 minuti di pausa e un posto si trova sempre”.
Parlare di produttività degli operai in quel clima faceva persino ridere. La situazione era pesantissima, economicamente e politicamente. “Rapporti sindacali tesissimi, infiltrazioni eversive, collegamenti diretti col terrorismo” – racconterà lo stesso Romiti -. Tanti anni dopo pare impossibile ma, a parte gli assassini terribili di Casalegno e Ghiglieno, spararono a sessanta dipendenti. Dico: sessanta dipendenti vittime di attentati! Era invivibile. Invivibile”.
Per arginare la situazione, mette uno dei “suoi” a Mirafiori, come capo del personale della Fiat auto, Carlo Callieri, detto John Wayne perché girava per la fabbrica con una pistola infilata nella cintura. Occhi di ghiaccio, un vero duro che vuole la linea dura. Romiti è con lui, ma “eravamo soli”. La politica ha altro a cui pensare. L’adesione allo Sme (il sistema monetario europeo che doveva servire a raggiungere la stabilità monetaria) mette in crisi il rapporto tra Dc e Pci – sono gli anni del compromesso storico e della politica dei sacrifici che tanto piaceva a Berlinguer e a Lama. Cade il governo, si va alle elezioni. Gli stessi sindacati non sanno come reagire (“per viltà, per paura, per comodità”- sempre Romiti) al fatto che si ritrovano i brigatisti – o i loro fiancheggiatori – in fabbrica.
Le Brigate Rosse in FIAT
Sono nati i CUB, comitati unitari di base, che trattano Cgil, Cisl, Uil come dei venduti. Insomma, il caos. Dall’altra parte gli Agnelli – soprattutto Umberto – provano ostinatamente la linea morbida, cercando di coinvolgere governo e sindacati. Ma, come abbiamo detto, con poca fortuna. In realtà la classe politica non ha ancora capito quanto fosse penetrato a fondo quel clima “rivoluzionario”, quanto fosse grave.
E’ esemplare una canzone che andava molto nei gruppi di estrema sinistra, non a caso chiamata La ballata della Fiat : “Signor padrone questa volta per te è andata proprio male… Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai… D’ora in poi se vuoi trattare dovrai rivolgerti soltanto a noi. […] Se offri 10 noi vogliam 100, se offri 100, mille noi vogliam. Cosa vogliano? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà”. Penso che renda l’idea.
Alla fine dell’estate del 1979 entrano in sciopero a tempo indeterminato gli operai del reparto verniciatura contro la riduzione delle pause di lavoro dovuta alla ristrutturazione del reparto, voluta dal sindacato, che aveva migliorato l’ambiente lavorativo piuttosto malsano ed era costata un bel po’ di soldi all’azienda. Romiti si infuria e dà al sveglia ai due Agnelli: stavolta andiamo giù duri. Passano pochi giorni e le Brigate Rosse uccidono Carlo Ghiglieno, responsabile della pianificazione e della logistica. Una decina di giorni dopo il suo funerale, sempre le BR gambizzano Cesare Varetto , responsabile delle relazioni sindacali nelle carrozzerie di Mirafiori. Sono diventati cinque i dirigenti uccisi e una sessantina quelli feriti. Si scoprirà nel 1982 che le Br avevano anche la piantina della casa di Romiti a Roma, che avrebbe dovuto servire a sequestrarlo.
L’azienda ha occhi e orecchie ovunque nei reparti e più o meno sa chi è brigatista o fiancheggiatore. E la linea del dialogo dei due Agnelli va a farsi benedire. Si passa allo scontro, Romiti in testa come un condottiero che guida le truppe all’assalto. Licenziamento per 61 operai, tutti del settore auto, ritenuti autori o sobillatori delle violenze. Il sindacato insorge e proclama uno sciopero. È un clamoroso flop. Sono gli stessi operai comunisti a non voler scioperare per difendere “quelli che ogni giorno ci picchiano, ci insultano, ci chiamano servi dei padroni solo perché vogliamo lavorare in pace” – scrivono all’Unità, il giornale del Pci. Una parte del partito comunista si sveglia. Amendola fa una dura reprimenda ai suoi e al sindacato per non aver saputo contrastare le violenze in fabbrica: “ricordano troppo – scrive – le violenze fasciste per non suscitare uno sdegno e un disgusto che invece non si è manifestato”. Lama sollecita la Cgil ad abbandonare le ambiguità. Entrambi avranno seguito fino ad un certo punto. Molti nel Pci e dintorni continuarono a pensare che, al di là della portata dei singoli episodi, la Fiat avesse preso spunto proprio da questi per sferrare un attacco al movimento dei lavoratori. Dalla Dc dichiarazioni di circostanza, e un non detto, ma accarezzato e solo da alcuni genericamente esplicitato (Donat Cattin) progetto di convergenza tra Fiat e Alfa Romeo, sotto la mano pubblica. Ma or non è più quel tempo e quell’età, per citare Carducci. Anzi, vedremo in seguito che sarà la Fiat a comprare l’Alfa Romeo, praticamente regalata dal governo.
Romiti e Callieri quindi vanno avanti. La misura era colma e se ci fossimo fermati sarebbe saltata l’intera struttura dell’azienda – dirà Gianni Agnelli che ormai ha capito che dal governo, in quella fase c‘è poco da aspettarsi. Nessuno dei 61 tornerà in fabbrica. Cesarone lo aveva giurato: o io o loro.
1980: Cuccia “incorona” Romiti capo assoluto di FIAT
E arriviamo al 1980, l’anno chiave non solo per la Fiat. L’anno che cambierà le relazioni industriali, il rapporto tra sindacati e partiti (“persino il Parlamento non può fare niente se c’è il veto dei sindacati” – parole di Gianni Agnelli). In definitiva cambierà un pezzo di storia recente d’Italia. Lo scenario per la casa automobilistica è disperante: 8.500 miliardi di debito, le banche premono, le immatricolazioni sono scese in 10 anni dal 75% al 51; la produttività è la più bassa d’Europa: nel 79 sono state prodotte 200 mila auto in meno a causa degli scioperi. Il clima in fabbrica, nonostante il licenziamento dei 61, è ancora pesante; e forse proprio per questo per i più estremisti c’è voglia di rivalsa.
Prendendo spunto dall’ennesimo calo di vendite all’estero, ai primi di maggio si chiede la cassa integrazione a zero ore per 78 mila dipendenti. Una decisione che lascia perplessi perché fino a pochi giorni prima in Fiat c’erano state assunzioni. In azienda era tornato Umberto come vice presidente (carica mai abbandonata anche da senatore) e amministratore delegato. E’ lui che vuole guidare la carica, ma una serie di scivoloni lo costringono a mettersi in panchina.
E’ intervenuto Cuccia – lui che restava sempre nella sua sede di Milano, si reca addirittura a Torino per parlare con Gianni. Spiega al sovrano che le banche vogliono drastiche iniziative per ridare competitività all’azienda, che queste iniziative devono essere in mano ad un solo uomo: Romiti. Il che comporta la rinuncia – e su questo Cuccia è irremovibile – di Umberto alla carica di amministratore delegato. L’avvocato china la testa, il fratello trattiene l’ira, la Borsa festeggia e Cesare è di nuovo un uomo solo al comando. E va giù duro. Il 10 settembre 1980 chiede 14 mila licenziamenti.
Il sindacato questa volta risponde con una mobilitazione possente. Al suo fianco si ricompatta il Pci. Il sindaco di Torino (Pci), in una delle tante manifestazioni che si svolgono in città, arringa gli operai: “se qualcuno pensasse di insistere nel far passare con la forza quel disegno, ebbene noi non saremo davanti ai cancelli di Mirafiori, ma saremo dentro Mirafiori” (Giancarlo Galli). Pochi giorni dopo sarà Berlinguer in persona, proprio davanti ai cancelli di Mirafiori, a ripetere il concetto.
Questo va detto, tanto per chiarire. Perché anni dopo, a sinistra, si cercherà di ridimensionare la portata delle parole del capo del Pci: era semplice solidarietà. No, era una precisa linea politica per dimostrare l’incapacità del governo di sciogliere importanti nodi sociali.
Il governo promette aiuti finanziari ma a condizione di rinunciare ai licenziamenti e il 20 settembre il presidente del consiglio Cossiga autorizza la giapponese Nissan per l’acquisto dell’Alfa Romeo. “E’ un evidente ricatto politico alla Fiat” – scrive Galli.
Cade il governo, la politica, tanto per cambiare, è di nuovo incasinata. Formica, ministro dei trasporti, convoca Romiti, lo dichiara responsabile della crisi governativa e gli chiede di tornare sui suoi passi. Ma Cesarone non ci pensa neppure. Ha aspettato che tutto fosse cotto a puntino e il 29 settembre annuncia la messa in cassa integrazione di 23 mila lavoratori, a partire dal 6 ottobre. Non è un annuncio generico: fa mettere in ogni reparto gli elenchi con i nomi di chi deve andare a casa e chi può restare a lavorare. E’ una bomba, perché una cosa è una astratta minaccia di licenziamenti “che aveva unificato il fronte operaio” (Marco Revelli: i 35 giorni alla fiat), ben altra è vedere il proprio nome sulla lista di proscrizione. “Paradossalmente coloro che sono sfuggiti alla decimazione e che rimangono in fabbrica sarebbero stati chiamati a lottare (e a perdere il salario) contro l’espulsione di 23 mila loro compagni che manterrebbero quasi intatta la paga”- scrive sempre Revelli. La mossa di Romiti è geniale: spacca il fronte interno e con la presa di posizione di Berlinguer può dimostrare che i suoi “nemici” sono degli estremisti. Ed è convinto che il resto del paese proprio per questo si schiererà con lui.
Comunque Mirafiori non viene occupata. Cgil, Cisl e Uil dichiarano sciopero a oltranza a Torino e sciopero generale in tutta Italia. Non per questo non si continua a trattare informalmente, anche se a Mirafiori ci sono picchetti ai cancelli giorno e notte e la produzione è ferma. Il 6 ottobre i “salvati” entrano in fabbrica. L’ingresso viene invece sbarrato a capi, capetti, impiegati. Ci sono anche degli scontri ma la polizia non interviene e anzi il ministro degli Interni Rognoni telefona agli Agnelli chiedendo, in pratica, di cedere. Tutto il mondo politico è convinto che sarà la Fiat a dover desistere.
Ma Romiti non molla. Forse non molla perché sottobanco ha già preparato una contro mossa, che non ammetterà mai. Ovvero la marcia dei 40 mila. I quadri intermedi della fabbrica che non possono lavorare e sono costantemente presi di mira. Sono in prima linea a contatto con tutti gli operai, anche i più facinorosi. Spunta fuori un personaggio, Luigi Arisio che organizza per il 14 ottobre un’assemblea dei capi e capetti che si trasforma in una manifestazione di piazza. La borghesia torinese è stanca del clima di violenza in città, è spaventata dalla possibilità che la Fiat chiuda veramente. E più il corteo procede, più gente comune si unisce (almeno, così dichiarerà Arisio). Non ci sono urla, solo striscioni: “diritto al lavoro” oppure “Novelli fa riaprire i cancelli”. Occupano Piazza San Carlo e Piazza del Municipio, ovvero i luoghi iconici delle manifestazioni operaie.
“Non siamo qui perché ce lo ha chiesto John Wayne – urla Arisio rivolto ai sindacati – ma perché avete usato male il vostro potere”.
Nello stesso pomeriggio la procura della repubblica ordina ai picchetti di smobilitare, mentre a Roma riprendono le trattative ufficiali al ministero del lavoro. In realtà, più che di trattative si tratta di una presa d’atto della sconfitta di Cgil, Cisl, Uil. Racconta Romiti: “parlò Lama per tutti e disse: la vertenza è finita, abbiamo perso”. Il Bismarck di Corso Marconi non ha vinto, ha stravinto.
Articolo 1 di 2. Continua con l’articolo “Cesare Romiti e le lotte di potere in Fiat: Cuccia docet“.