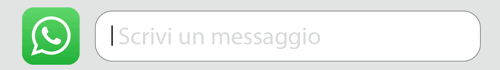Luigi Mazzella, già Avvocato Generale dello Stato e Giudice Costituzionale, è uno studioso delle istituzioni. Ha collaborato in posizioni di responsabilità con molti ministri ed ha scritto numerosi saggi di diritto pubblico ed alcuni romanzi.
Abbiamo incontrato l’Avv. Mazzella e gli abbiamo posto alcune domande, spunto per riflessioni sull’attuale situazione socio politica italiana.

Molto spesso capita al cittadino di non riuscire a comprendere atti e comportamenti dei protagonisti della vita politica. L’Italia è veramente, come si afferma spesso all’estero, il paese delle trame, della politica come opera d’arte, insomma il paese di Niccolò Machiavelli?
L’Europa, ignorando in maniera pervicace e ostinata l’insegnamento di Machiavelli, ha sempre confuso l’attività pratica necessaria alla conduzione della polis, con la morale e, peggio ancora, con la precettistica religiosa e con assiomi etici. In buona sostanza, se oggi il mondo occidentale si è spaccato lo si deve al fatto che il suo polo anglosassone ha seguito la dottrina di Machiavelli circa la distinzione tra politica e morale, e l’altra, l’Europa continentale non è riuscita a sceverare l’una dall’altra, non liberandosi dalla soggezione ideologica all’ebraismo, al cristianesimo, al platonismo e all’idealismo tedesco.
In conseguenza di ciò, mentre i Paesi Anglosassoni, sono indotti a ricercare soluzioni dirette a risolvere i problemi concreti delle loro rispettive comunità, gli altri popoli europei sembrano condannati all’osservanza acritica di astratti doveri morali, laici o religiosi che siano. In altre parole, soltanto nella parte anglosassone del mondo Occidentale appaiono destinati a persistere, ancora vivi e vitali, i sistemi “liberal democratici” caratterizzati da pragmatismo, utilitarismo, capacità di garantire una buona convivenza sociale ai cittadini; nell’Europa continentale, no.
Questo spiega anche la durezza dello scontro politico in momenti come quello attuale?
La trasformazione della lotta politica in una sequela di battaglie ritenute di grande valore etico o religioso è stata una “costante” europea con corollari d’intolleranza, di ferocia, di ostilità invincibili. La volontà di distruggere il “nemico”, infedele o schiavo del Male, è apparsa sempre indomabile. Le guerre cosiddette di principi inviolabili e di sommi valori, le contrapposizioni fideistiche per scismi ed eresie di varia specie, per consuetudine inveterata, “non fanno prigionieri” e “non lasciano feriti sul campo di battaglia”.
In più, il Vecchio Continente, per le sue tendenze manichee, è caduto più e prima di ogni altra parte del mondo, anche nella trappola dei conflitti tra orientamenti ideologici violenti, sedicenti salvifici e volti al Bene dell’umanità ed i massacri reciproci tra fascisti e comunisti non sono mancati. Alle guerre tra fedi religiose, si sono aggiunte quelle per perseguire gli obbiettivi indicati dai venerati Maestri del pensiero post-hegeliano.
In Italia, non sono neppure mancate le alleanze contingenti che ogni guerra comporta: a una prima intesa clerico-fascista ne è seguita un’altra catto–comunista che ancora, sia pure sotterraneamente, perdura. In definitiva, in uno scenario presso che uniforme, i soli nemici della Politica intesa come Morale sono sempre stati e continuano a essere i pensatori liberi, gli empiristi, i pragmatici, i cultori del dubbio e della tolleranza, i ricercatori esasperati di soluzioni pratiche a problemi veri e concreti, privi dei paraocchi delle fedi e delle ideologie ritenute etiche e morali.
Come si ripercuote tutto questo sulla situazione economica?
Le cause del crollo del sistema economico possono essere tante. Le forze politiche egemonizzate dai cristiani (di varia denominazione), dai socialisti democratici e dalle organizzazioni sindacali, pur operando in modo giusto (nell’intento di perseguire un’equa giustizia sociale per portare nell’area del benessere, o quanto meno dell’autosufficienza, molte categorie di lavoratori che prima non riuscivano a sbarcare il lunario) hanno fatto, certamente, lievitare i costi della mano d’opera. Ciò ha creato difficoltà alla produttività delle imprese, rendendo i prezzi dei manufatti delle liberal democrazie più costosi e quindi non competitivi con quelli offerti sul mercato da Paesi dittatoriali, autoritari o emergenti.
Una corretta ed esauriente cognitio rei per causas, però, non può fermarsi qui. Occorre valutare, per esempio, se alcuni principi della cultura liberale tradizionale, relativi allo scambio delle merci ed ai movimenti umani, siano responsabili, non meno degli altri fattori indicati, dell’attuale debàcle dell’industria manifatturiera. E ciò, a causa delle mutate condizioni dello status dei lavoratori nei Paesi democratici e in quelli autoritari o dittatoriali. In altre parole, occorre chiedersi se per salvare l’industria manifatturiera occidentale ed eliminare il suo gap, non si debba ritornare al sistema dei dazi doganali.
Di tali condizioni inumane e sfacciatamente favorevoli al datore di lavoro, pubblico o privato che sia, e del surplus di marxiana memoria, hanno imparata ad approfittare anche operatori economici occidentali (con o senza pelo sullo stomaco). E ciò hanno fatto (e fanno) “delocalizzando” dagli Stati europei o nord-Americani i loro opifici in quelle zone, impoverendo i primi e arricchendo le seconde. In tal modo, infatti, privano il proprio Paese d’origine di utili industrie manifatturiere (potenzialmente produttive di ricchezza) e, al tempo stesso, i loro connazionali lavoratori del sostegno economico essenziale per vivere.
Se con la reintroduzione dei dazi, l’attività produttiva diventa nuovamente competitiva con soddisfazione delle imprese e dei lavoratori, la domanda è: dove sta il “misfatto”? E’ proprio deplorevole proteggere il proprio Paese e i suoi cittadini? Perché dovrebbe essere “vietato” indurre i “delocalizzatori”, con misure doganali adeguate, a rientrare nei patri confini, per dare ricchezza al proprio Paese e lavoro ai propri connazionali? Si dice, allora, con l’intento di lanciare un terribile anatema, che il ripristino dei dazi, pur andando tutto a beneficio dei datori di lavoro e degli operai nazionali sarebbe, comunque, “protezionismo”, perché si tratta di un’attività di favore e di sostegno nei confronti delle imprese del proprio Paese, industriali e commerciali e che ciò costituirebbe un ingiusto “favoritismo”!
L’argomentazione è strampalata, illogica e stravagante sotto diversi profili. Il termine “protezione” ha sempre una connotazione positiva se si parla di natura, di ambiente. Diventerebbe, non si sa perché, “negativo” se la protezione riguardasse le persone e il frutto del loro lavoro. In altre parole, le liberal democrazie proteggendo le proprie industrie e gli operai che vi lavorano costituirebbero “il male”; gli Stati dittatoriali o autoritari, utilizzando gli operai come semi-schiavi, rappresenterebbero l’emblema del “bene”.
C’è un filo logico in tale ragionamento? Ed è razionale pensare che i governanti di uno Stato liberal democratico non debbano proteggere i propri cittadini, tutelando i loro interessi materiali? Di che cosa altro dovrebbero occuparsi? Al bene dell’anima di tutti gli esseri umani ci pensano a livello ecumenico le autorità religiose. Non è giusto tenere distinte le due sfere d’azione ed evitare confusioni tra il sacro e il profano?
Come mai voci in questo senso non si levano in Parlamento?
Con la supponenza di vecchi maestri di democrazia, i nostri connazionali e gli abitanti di terraferma del vecchio Continente, in generale, confinano sempre le cosiddette “Repubbliche delle Banane” nel Continente nero, nell’America centro-meridionale e in altri luoghi lontani e distanti da quello che ritengono il centro del Pianeta, il cosiddetto “ombelico” del mondo, l’Europa.
Con altrettanta altezzosità, i docenti delle Accademie Euro-continentali, figli di una cultura che ha disconosciuto le sue origini-greco romane facendosi adottare dalla favolistica mediorientale, insegnano ai popoli, ritenuti meno progrediti, quale debbano essere i connotati salienti di una comunità civile ed evoluta e discettano di “vera democrazia”, illustrando i suoi riti elettivi, l’iter dettagliato delle leggi nonché le regole di quella che ritengono una buona amministrazione e una corretta giustizia.
Per quanto riguarda il Bel Paese, quegli illustri luminari, insegnano che il Parlamento italiano, espressione del popolo sovrano, approva una legge, dopo averla discussa, (ed aggiungono spesso: approfonditamente) in Commissioni ad hoc ed in aula; che il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, la promulga, se non ritiene di doverla rimandare alle Camere; e ciò, dopo averne esaminati, con esito positivo, gli aspetti più delicati di natura costituzionale; che a livello locale, il Sindaco garantisce l’applicazione di ogni provvedimento nazionale nella sua città o nel suo più circoscritto comune, per tutelare gli interessi dei cittadini. Parlano anche di organi di giustizia, enumerandone, senza particolare accento critico, la moltitudine.
Non dicono, quei maestri del pensiero giuridico, che mentre in Paesi ben ordinati e civili, tale sequenza è sempre applicata a puntino e non dà luogo a problemi e a conflitti tra le istituzioni, non sono rari i casi in cui le cose, in Stati come quello italiano, vanno ben diversamente. Il Parlamento, quello ancora eletto dal popolo (ma c’è già chi propone di abolirlo) anche se solo tra candidati prescelti dei capi-partito, approva una legge senza discussione e dibattito adeguato nelle sedi deputate, soggiacendo sostanzialmente ai diktat dei leader della maggioranza di governo (che nei casi, dove i riflessi economici sono più evidenti devono ottenere, a loro volta, il prioritario, anche se riservato o segreto, placet dei commissari e dei burocrati dell’Unione Europea) e proponendo ripetutamente la questione di fiducia su maxi-emendamenti “chilometrici” illeggibili e comunque verosimilmente non letti (o persino non compresi chiaramente) dai cosiddetti o sedicenti rappresentanti del popolo; il Capo dello Stato firma il provvedimento, anche se, su aspetti diversi dalla costituzionalità, le osservazioni giuridiche dei suoi uffici e la sua personale opinione (contenute in note di accompagnamento riservate e del tutto “anomale”) sono state sostanzialmente disattese dal Parlamento (per la malcelata dipendenza delle Camere legislative, a dispetto della conclamata “centralità”, dai capi partito al vertice del Governo del Paese), pur non investito ufficialmente, ratione materiae, di un formale invito (messaggio) a riesaminare il testo; i Sindaci delle città e dei Comuni interpretano il loro ruolo di tutela degli interessi della comunità, prescindendo, talvolta, dalle valutazioni che di essi hanno fatto, in tempi successivi, il Parlamento e il Presidente della Repubblica e rifiutandosi, in alcuni casi divenuti eclatanti, di dare applicazione a una legge dello Stato. Ciò che, eventualmente, decidono in tali materie incandescenti giudici di plurima e variegata competenza è nelle mani di Dio, per un fedele monoteista, sulle ginocchia di Giove, per un pagano, o dipendente dal Caso, per un laico non credente.
Pensa sia necessario procedere sulla strada delle modifiche costituzionali?
L’impasse che, in altri tempi, avrebbe potuto costituire il priusper di una “rivoluzione” costituzionale profonda, anche se non necessariamente violenta (Charles De Gaulle e la Quinta Repubblica francese docet) ma con tanto di Assemblea Costituente e fior di giuristi chiamati al capezzale del moribondo Bel Paese, oggi appare senza via di uscita. Nessuno che sia stato investito del potere di gestione della res publica pensa di non avere un intoccabile diritto di continuare a fare il bello de il cattivo tempo in un Paese da sempre aduso ad accettare tutto.
Quando un leader politico della maggioranza di governo, Matteo Salvini, parla di riforma costituzionale in direzione di una Repubblica semi-presidenziale (alla francese), la mente e il cuore degli Italiani si aprono alla speranza. Non perché il modello che ha portato Sarkozi, Hollande e Macron a gestire il destino dei nostri “cugini d’oltrealpe” sia visto come una manna che potrebbe cadere sul suolo italico per liberarci da talune presenze politiche inquietanti, ma perché comporterebbe la necessità di cambiare il sistema di voto e di applicare in Italia il maggioritario uninominale (e di uscire, quindi, dall’attuale gabbia del voto ai nominati dai capi-partito).
Su tale proposta, però, è subito calato il silenzio e con esso le speranze di uscire dal cul de sac in cui gli Italiani sono stati cacciati dai protagonisti del “decennio nero” e degli anni ad esso successivi. La situazione è drammatica. Già a livello europeo, il potere oligarchico dei finanzieri, che controlla saldamente l’Unione Europea, attraverso i tecnocrati di Bruxelles, ha privato non solo gli Stati-membri ma anche le loro popolazioni di ogni sovranità e possibilità di determinare il loro destino.
La rivolta parigina (e di altre cittadinanze francesi) dei gilet gialli (che si convocano per le loro attività distruttive, soprattutto incendiarie, solo per i week-end) la dice lunga sulla sostanziale afonia, nell’era della sovrapposizione dei suoni, della vera e diffusa vox populi.
Sullo Stivale, lo stesso effetto si è verificato in misura esponenziale: il motto dantesco della “nave senza nocchiero in gran tempesta” è diventato più valido che mai, perché il nostro servaggio (“ahi serva Italia!”) al potere finanziario impersonato dai burocrati euro-continentali e la nostra confusione costituzionale e istituzionale sono figlie di un disvalore aggiunto tipicamente italiano: la zuffa permanente, quasi “esclusiva” tra fanatici di ideologie, religiose e politiche, ugualmente assolutistiche e prevaricanti, pur se rivestite da una melliflua, furbesca, falsa e ipocrita volontà di dialogo.
In un Paese in cui la stragrande maggioranza dei cittadini si ritiene detentrice di certezze dogmatiche, nessuno riesce a convincere gli altri a rinunciare alla propria verità. E’ noto che purtroppo le discussioni possono avvenire solo tra cultori del dubbio e della tolleranza: due entità del tutto sconosciute al Bel Paese.