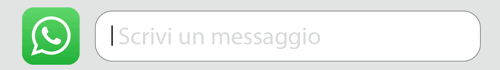Se il termine utopia avesse bisogno di un volto, quel volto sarebbe di Adriano Olivetti.
Imprenditore, editore, sognatore, ingegnere, urbanista, filosofo, filantropo. Politico di una politica che allora era troppo avanti. Anzi, è troppo avanti ancora oggi.
“Cio’ che distingue la storia degli Olivetti da quella delle altre famiglie è che i suoi annali sono scritti entro le mura ideali della fabbrica più che nei consigli di amministrazione”, racconta Geno Pampaloni, scrittore e storico letterario che per 12 anni è stato stretto collaboratore di Adriano. Faceva parte, dal 1947, di quel trust di cervelli che l’imprenditore aveva voluto vicino a lui. Filosofi, sociologi, architetti, urbanisti, poeti, designer. Perché, diceva: “Io voglio che la Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici!”
La sua idea era che l’impresa dovesse essere non solo un soggetto economico ma anche una istituzione sociale, e “perciò investita del compito di contribuire al progresso civile e alla modernizzazione del Paese” (Castronovo).
E in qualche modo ci riesce. Ma il sognatore non oscura mai l’industriale. Anomalo, ma pur sempre industriale, figlio di un industriale. Adriano sapeva programmare, studiare e vendere il prodotto, produrre profitto e dividendi per la famiglia e gli azionisti.
“I soldi venivano non da strategie cartacee o da ideologismi sociologici, né tantomeno dalla finanza e dalle concessioni dello stato, ma dal tecnigrafo, dalla linea di montaggio e dai negozi”, scrive Giorgio Garuzzo (che in Olivetti ha lavorato, ma dopo la morte di Adriano) nel suo libro “Quando in Italia si facevano i computer”. Perché anche questo ha fatto Olivetti: i primi computer.
Nasce a Ivrea nel 1901, da padre ebreo e da madre valdese. Socialista come il padre Camillo (che nel 1908 aveva fondato la fabbrica di macchine da scrivere), ma di un socialismo diverso: si era fatto cattolico ed era più vicino al filosofo cattolico francese Jacques Maritain che non a quello tradizionale. Anche se insieme al padre, aiuta Turati ad espatriare.
Frequenta Torino, negli anni ’30 una fucina del liberalsocialismo, “dell’impegno fattivo, del raccordo dell’azione con l’ideale”, come scrive Vittorio Foa nella sua autobiografia Il Cavallo e la Torre. L’ambiente è quello di Carlo Levi, Vittorio Foa, Renzo Giua, Massimo Mila, che saranno poi tra i fondatori di Giustizia e Libertà. Torino – scrive sempre Foa – era “…uno scontro tra turbolenze ed efficienze”. Adriano assorbirà fino in fondo questa cultura. Antifascista, si fa un anno a Regina Coeli, deve scappare in Svizzera. La scrittrice Natalia Ginzburg – Adriano sposerà sua sorella Paola – nel suo Lessico famigliare lo descrive “timido e silenzioso ma quando parlava, parlava allora a lungo e a voce bassissima, e diceva cose confuse e oscure fissando il vuoto coi piccoli occhi celesti, che erano insieme freddi e sognanti”.
Sognante certamente, ma tutt’altro che confuso. Si laurea in ingegneria e va studiare più di cento fabbriche negli Stati Uniti. Soprattutto la Underwood, che nel 1896 aveva brevettato la prima macchina da scrivere. Per il padre la Underwood era un mito. Per Adriano molto meno. Lui aveva una nuova visione di impresa, basata sull’organizzazione decentrata del personale e sulla razionalizzazione dei tempi e dei metodi di montaggio, altro che taylorismo! Quello che cercava era l’equilibrio tra profitto, democrazia e giustizia sociale.
Da ragazzo il padre lo aveva mandato in fabbrica a fare l’operaio per conoscere l’azienda “dal basso”. L’esperienza gli insegna molto. Gli fa toccare con mano cosa vuol dire un lavoro alienante e ripetitivo. “Conoscevo – racconterà anni dopo – la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all’infinito davanti a un trapano o a una pressa, e sapevo che era necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù. Bisognava dare consapevolezza di fini al lavoro”.
Olivetti e la fabbrica eticamente sostenibile
Per questo, una volta assunto il comando dell’azienda, vuole fare una fabbrica del tutto diversa, che rispondesse a ritmi ed esigenze umane, eticamente sostenibile. Una fabbrica in cui il lavoro si potesse trasformare, appunto, in libertà e piacere.
Utopia? Per Olivetti non è affatto così: “Spesso il termine utopia – diceva – è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande”. E si butta a capofitto nel cambiamento. Trasforma l’architettura dello stabilimento, mette in piedi un welfare per gli operai, che non ha eguali (altre industrie lo avevano da tempo, ma quello della Olivetti è di più alta qualità). Nel 1956 abbassa l’orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali a parità di salario, in anticipo di diversi anni sui contratti nazionali, e alza le retribuzioni. Dà un permesso retribuito di 9 mesi per le operaie incinte. Gli altri industriali gli si scatenano contro, ma lui se ne infischia anche perché il suo atteggiamento alza, e di molto, la produttività in fabbrica.

Inoltre nel dopoguerra è il solo, insieme a Valletta, a credere nella produzione di massa. Ma mentre a Torino Valletta creava alla Fiat i reparti confino per gli operai di sinistra, Olivetti ai suoi operai di Ivrea diceva: “in questa fabbrica non abbiamo mai chiesto a nessuno a quale fede religiosa credesse, in quale partito militasse o da quale regione d’Italia provenisse”. Nel 1948 Olivetti dà vita al consiglio di gestione, per molti anni unico esempio in Italia di organismo paritetico con poteri consultivi sulla destinazione dei finanziamenti per i servizi sociali e l’assistenza. La particolarità è che il consiglio li gestiva direttamente, sottraendoli quindi ad una amministrazione inevitabilmente paternalistica del padrone.
Adriano lo concepisce come “una forma stabile di cooperazione fra le varie componenti della popolazione di impresa. La sua natura ibrida esaltava i momenti di commistione e compenetrazione tra forme di collettivismo economico e di efficienza capitalistica. Era la prima tappa verso l’attuazione di un progetto di cogestione del potere aziendale, cui Adriano non rinunciò mai” (Giuseppe Berta “L’Italia delle fabbriche”). Anche in questo avanti anni luce rispetto al resto dell’industria italiana. Per i consigli di gestione, Olivetti si avvale della consulenza di due intellettuali socialisti, Momigliano e Fortini. Stiamo parlando degli anni 50, anni di guerra fredda e di contrapposizioni violente. Questa operazione dei consigli, in più ispirata da due socialisti, per il mondo che conta in quel momento è veramente eresia. Persino gli americani cominciano a guardarlo con sospetto. Ohibò, un industriale comunista!
Invece il suo non è comunismo, ma il comunitarismo. Fonda un movimento chiamato proprio Comunità che “coniugava il federalismo con la democrazia e il progresso economico con la cooperazione sociale” (Castronovo) . L’idea era che la fabbrica dovesse essere profondamente radicata nel territorio e che il territorio potesse armonicamente superare la divisione tra agricoltura e industria, tra produzione e cultura. Una visione che cerca di conciliare gli ideali socialisti e la concretezza liberale. Una aspirazione utopica che non porta a grandi risultati politici: nel 1958 quando si presenta alle elezioni nazionali, è l’unico eletto (poi lascerà il posto a Ferrarotti).
Ma Comunità va avanti e diventa una casa editrice (esiste ancora) e Adriano finanzia anche la nascita del settimanale L’Espresso, che venderà nel 1957, a causa delle difficoltà che la linea politica aggressiva del settimanale crea al suo gruppo industriale; dona il grosso delle sue azioni a Carlo Caracciolo e, in misura minore, a Benedetti e Scalfari.
La sua stella polare comunque resta l’azienda, intesa come momento di crescita collettivo. Si circonda di uomini di gran calibro cui affida anche ruoli in azienda: Leonardo Sinisgalli, poeta, capo dell’ufficio pubblicità; Paolo Volponi, scrittore, poeta e in seguito senatore comunista (scandalo!) direttore del personale. E poi Ferrarotti, sociologo, l’urbanista Astengo, il designer Sottsass, lo storico Castronovo. Ma dà anche grande spazio ai tecnici e agli ingegneri e alla loro formazione. Anzi, scommette proprio su di loro.
Archiviata l’esperienza parlamentare Olivetti continua con la fabbrica. Perché, come abbiamo detto, il sognatore non prenderà mai il posto dell’imprenditore. Tra il 1946 e il 1958 le macchine da scrivere crescono di quattro volte, di nove quelle portatili. Le calcolatrici addirittura di 66. Nel 1950 nasce la mitica Lettera 22 (sarà prodotta fino al 1965), la piccola macchina da scrivere portatile usata dai grandi giornalisti (Montanelli, Biagi, Bocca) come dagli studenti. Un oggetto che ha accompagnato l’Italia del boom. Costa 44 mila lire ed è un successo strepitoso. Produzione e utili dell’impresa salgono vertiginosamente: Lettera 22 e Divisumma – la prima calcolatrice elettromeccanica al mondo in grado di svolgere tutte e quattro le operazioni e stampare il risultato – conquistano il 30% del mercato mondiale. Nel 1954 “Lettera 22” è premiata con il “Compasso d’Oro” per il design e nel 1959 indicata dall’Illinois Technology Institute come miglior prodotto degli ultimi cento anni in fatto di progettazione. Viene esposta al MoMA di New York, dove possiamo ammirarla ancora oggi.
Nel 1955 apre una fabbrica a Pozzuoli, in un momento in cui gli industriali del nord non pensano nemmeno lontanamente a scendere oltre la linea gotica. Scegliere il sud “è un punto di riferimento per le sue iniziative e i suoi progetti territoriali” (Berta). Agli operai che si radunano il giorno dell’inaugurazione dice che la nuova fabbrica “si eleva nel rispetto della bellezza dei luoghi affinché la bellezza sia di conforto nel lavoro di ogni giorno”. Ma è anche vero che tra il 51 e il 52 il governo ha offerto agevolazioni alle aziende disposte a spostarsi nel Mezzogiorno. Così come è vero che sulla zona aveva già messo gli occhi, la sua più diretta concorrente, l’americana Remington. Utopista si, ma con i piedi per terra.
Certamente sarà uno degli uomini cui si deve maggiormente la rinascita economica dell’Italia post bellica. La Olivetti è stata una delle aziende più importanti al mondo nel campo delle macchine da scrivere, da calcolo e dell’elettronica. Oltre a Ivrea e Pozzuoli, nel ’55 entrano in funzione gli stabilimenti di Agliè, nel ’56 di S. Bernardo di Ivrea, nel ’57 della nuova ICO a Ivrea e di Caluso. In Brasile, nel 1959 si inaugura il nuovo stabilimento di San Paolo. I dipendenti aumentano da poco più di 6 mila a 15 mila. “La ripresa economica vede così Olivetti fra le principali multinazionali italiane, ulteriormente rinnovata nella sua struttura produttiva e organizzativa” (Adriana Castagnoli e Emanuela Scarpellini Storia degli imprenditori italiani).
Olivetti e l’elettronica: i primi computer
Poi arriva la sfida più importante, quella dell’elettronica. Olivetti sa guardare lontano, si fida dei tecnici che gliela propongono e capisce che quello è il futuro, che prenderà il posto della meccanica. Già nel 1952 aveva aperto a New Canaan, negli USA, un laboratorio di ricerche sui calcolatori elettronici. Nel 1955 impianta il Laboratorio di ricerche elettroniche a Pisa; nel 1957 fonda con Telettra la Società Generale Semiconduttori (SGS) e nel 1959 introduce sul mercato l’Elea, uno dei primi calcolatori completamente a transistor; la Programma 101, il primo elaboratore personale da cui sono derivati gli attuali personal computer. Un successo che gli fa ottenere nel ’57 un premio dalla National Management Association di New York per “l’azione di avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale”.
Nel 1959 acquista il pacchetto di maggioranza della Underwood, “un traguardo che nessuno in Italia ancora qualche anno prima avrebbe potuto nemmeno lontanamente immaginare” (Castronovo). Un traguardo che gli costa caro: 9 milioni di dollari, più o meno 6 miliardi di lire del tempo. Secondo Giorgio Garuzzo (Quando in Italia si facevano i computer) “l’errore fu nel sotto-stimare l’arretratezza della Underwood e/o di sovrastimare la capacità di Ivrea di rimettere a posto la situazione”. L’azienda americana, infatti, è decotta e piena di debiti ma gli serve per installarsi saldamente nel mercato americano. Ed è un bel colpo di immagine: è la prima volta che un’azienda italiana ne compra una americana di tanto prestigio e tali proporzioni. E Olivetti all’immagine teneva molto. I tanti soldi spesi per architetti geniali come Ettore Sottsass, avevano come fine proprio quello di fare del marchio qualcosa di avveniristico. I negozi Olivetti erano negli anni ’60 praticamente quello che oggi è un Apple Store.
Ma non fa a tempo a portare a compimento tutto quello che ha messo in piedi. Muore il 27 febbraio 1960, stroncato da un ictus su un treno in Svizzera. Con la sua morte comincia la discesa agli inferi della sua azienda. Ci sono vari tentativi di salvataggio, arrivano soci come Agnelli e Pirelli, le banche. Il tutto con la regia di Cuccia. Ma nessuno di loro crede o capisce l’informatica (Agnelli e Pirelli, poi, avevano i loro problemi in azienda). La compra De Benedetti, ma di fatto la riconsegna all’ormai anacronistica vocazione meccanica. Dal 2003 fa parte del gruppo Tim.
Ma di Adriano Olivetti non rimane solo l’utopismo generoso di un imprenditore illuminato che ha contribuito a rivoluzionare il modo di fare impresa, anche se pochi, pochissimi l’hanno seguito. Rimane anche un grande regalo che ha fatto alla sua Ivrea. Con lui si sviluppa la città industriale, un insieme di edifici destinati alla produzione e ai dipendenti: uffici, abitazioni, mense e asili progettati da grandi architetti. Un complesso urbano che nel 2018 è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco: «Per la moderna visione della relazione tra industria e architettura».