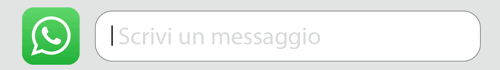La comunicazione e il “ben altro”
Quando le cose vanno storte, qualcuno se la cava dicendo che non si è stati capaci di comunicare. A volte è così, altre volte – quando sono in campo organizzazioni complesse con loro procedure e regole – la comunicazione è a valle di ben altro. E quel “ben altro” è fatto di cose che riguardano una lunga fila di requisiti per cui – tanto nelle aziende quanto nelle istituzioni – si esercita la difficile arte del comando. Competenza, controllo pieno dei dati reali, analisi comparative, staff professionale, vissuto esperienziale per pesare pensieri e parole, senso autocritico, autorevolezza, capacità di gerarchizzare i pericoli.

Giorno per giorno, da quando è stato proclamato l’allarme sul caso Coronavirus, si addita il deficit comunicativo. Ma come è spesso nelle cose del nostro Paese, sempre e su tutto “duale”, questa critica suona nel complesso ambigua.
C’è chi dice che si comunica poco, chi troppo. C’è chi dice che si comunica per spiegare le misure, chi dice che si comunica per litigare con chi vuole misure diverse. C’è chi dice che la comunicazione deve essere in capo a chi comanda, chi dice che deve essere in capo a chi la sa fare.
In Italia non vige il pensiero unico. Nella prima settimana la comunità scientifica si è spaccata attraverso vari conflitti. Il sistema politico-istituzionale ha fatto lo stesso. E – terzo soggetto sempre in campo – il sistema dei media si è rivelato contraddittorio, perché ogni volta è andato dietro agli uni e agli altri riflettendo un quadro più conflittuale di ciò che è tollerabile in piena crisi ed emergenza. Ebbene, alla fine di questo primo round è successa una cosa immaginabile. Prima dell’intervallo del fine settimana, ha parlato il massimo arbitro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con poche e severe parole: “attenzione a non sollevare paure, attenzione a non cedere a teorie antiscientifiche, attenzione a non prestarsi all’autolesionismo”. E’ lui, dunque, ad avere posto il problema di adeguare le narrazioni.
L’altro conflitto insorto, tra salute ed economia
Come si sa un quarto fronte si era formato nel frattempo, sollevato da chi ha cominciato a lanciare il tema dell’economia ferita che a poco a poco – anziché trovare forme di espressione convergenti con la priorità della salute – è diventato un tema antagonista rispetto alle dinamiche sanitarie, nel frattempo con impennate di numeri e di territori uno dopo l’altro inclusi (alla sera di mercoledì 4 marzo parliamo di oltre 3 mila contagiati, 276 guariti e 107 decessi).
A questo punto – entrati nella seconda settimana – il senso della comunicazione scomposta, della litigiosità oltre l’asticella, della conflittualità rispetto a tutti i soggetti in campo, ha superato la percezione di un volto diverso della realtà che aveva pure la sua verità e la sua legittimità: gente normale e volonterosa che si prestava (e si presta) ad attuare le misure; grande dedizione di medici e infermieri; impegno di amministratori e funzionari; governo all’opera per cercare di tenere salute pubblica e economia in equilibrio di prospettiva; media in pressione per assicurare una soglia elevata e razionale di adeguate conoscenze.
Insomma, la conseguenza della settimana scomposta ha fatto prevalere l’avvio del secondo round con una percezione più influenzata dalla confusione (che c’è stata) rispetto al coraggio operoso (che c’è stato).

La comunità scientifica a questo punto si è ricompattata. Ottenendo tra l’altro – probabilmente a spese della Protezione Civile (di cui è pure parte) – la sostanziale regia comunicativa pubblica. E si è ricompattata spostando chiaramente l’interpretazione generale dell’evento da un iniziale “tutto sotto controllo” a un definitivo “la situazione è grave”. Nessun altro dispone di dati salienti per mitigare questo giudizio. E quindi il sistema politico-istituzionale a questo punto ha accusato il netto passaggio, ha regolato le misure prese (secondo decreto) di conseguenza e ha cercato di attutire i conflitti inter-istituzionali, con un momento di cautela comunicativa.
“Qualcuno parli al Paese”
E qui è sbucato di nuovo il terzo soggetto a sparigliare. I media. Due giorni di tuoni (ore di maratone tv) contro la comunicazione “confusa” e poi il titolo cubitale in prima pagina di Repubblica, a firma del direttore Carlo Verdelli, “Qualcuno parli al paese”. Magari dietro l’idea di spostare dai media stessi (accusati sempre di allarmismo) alla politica l’accusa vagante di far confusione. Anche nel caso di Repubblica una cosa va detta: titolo giusto come tema cornice di ogni crisi di queste dimensioni; ma anche titolo forzato rispetto al momento in cui una certa ricomposizione si andava producendo.
E questa nuova onda ha determinato, con video circolante in tutte le tv e in rete, il ritorno comunicativo del capo del Governo, Giuseppe Conte, per spiegare il decreto e le nuove misure severe.
Chi scrive osservava già da giorni l’anomalia italiana, rispetto ad altri paesi europei, della politica – non quella dei partiti che sono pressoché eclissati rispetto alla crisi, ma quella che guida per mandato della maggioranza parlamentare le istituzioni – a volere usare tutti gli spazi possibili per spiegare ai cittadini passo passo gli eventi della crisi (in particolare nel sistema regionale, ma il via a questo walzer lo avevano dato all’inizio sia Salvini spingendo per l’estremizzazione sia lo stesso Conte per parare Salvini con la sua ubiquità rassicurante in tutto il sistema tv).

E’ evidente che in momenti cruciali il leader – nazionale o regionale – deve dare un segnale, possibilmente sobrio e non retorico, di responsabilità in ordine alle misure assunte. In questo c’è anche una responsabile assunzione di possibili impopolarità. Ma poi è compito della comunicazione istituzionale – intesa come sistema delle responsabilità tecniche – di spiegare, contare, argomentare, indirizzare, proibire, sollecitare, eccetera. Mai con l’idea che si sta facendo battaglia politica, mai con l’idea che dietro a quella comunicazione c’è lucro di consenso.
Qui gli errori commessi sono di sistema. Sono di crisi diffusa di classe dirigente. E di evaporazione di una cultura di comunicazione istituzionale resistente e radicata. Anche se chi scrive deve dire che questa volta la comunicazione del premier Conte non va iscritta negli errori, nel senso che almeno questa volta a lui toccava assumersi la responsabilità delle misure.
Cosa serve ora?
Adesso, di nuovo, servirebbe un momento di bocce ferme per una regolata metodologica generale. Comunità scientifica, politica, imprese, amministrazioni e sistema mediatico, senza dover fare vistosi summit propagandistici, sanno come parlarsi per tentare di uscire dalla contorsione del giorno per giorno, del caso per caso, del marketing che insegue le paure.
Le comunità locali, stanno dando un buon esempio, cercando di trovare parole comprensibili e tollerabili per vivere il duro passaggio (per alcune di loro durissimo) e conservando tolleranza e solidarietà. Abbiamo in casa molte testimonianze di buonsenso collettivo che possono diventare paradigma di una cultura nazionale di governo della crisi.

E in alcune di queste comunità territoriali le università – qui e là ci sono casi interessanti – diventano un luogo abbastanza neutrale e con public engagement per dare parole e pensieri al proprio territorio.
La dimensione nazionale dispone però di risorse, luoghi di eccellenza, competenze, relazioni internazionali per entrare nella fase tre, quella in cui anche la comunicazione può finire per diventare virtuosa. Non perché da essa dipenda tutto. Ma perché quando funziona la regia generale, funziona anche l’immagine e la reputazione. Che non è cipria, ma leva credibile per contrastare lo sciacallaggio che si segnala giorno per giorno in mezzo mondo (ieri l’indecente spot su Canal+ in Francia sulla Pizza Corona) e per il quale rischia di essere davvero cipria la pura irritazione della nostra Farnesina.